Monkey island è il nome di un fortunato videogioco che faceva furore su per giù negli anni’90 al quale francamente non credo di aver mai giocato ma che ricordo trastullava parecchi miei amici: era una sorta di caccia al tesoro con indizi disseminati qua e là e come tale teoricamente congeniale ai miei gusti ma devo dire che ho sempre avuto una certa ritrosia verso questi passatempi, anche perché mi è sembrato sempre piuttosto evidente la velocità con cui provocano uno scollamento dalla realtà in che ne abusa. Ad ogni modo un posto chiamato “isole delle scimmie” in Vietnam ci mette poco a rapirti la fantasia se hai voglia di avventura e così mi dirigo la, non capendo manco bene dove sia ubicata.
 siamo in effetti nella famosa Halong Bay, cento km a sud di Hanoi, e parliamo di un isolotto nei pressi della più estesa Cat ba. Un posto magnifico, si tratta di arrivarci ora.
siamo in effetti nella famosa Halong Bay, cento km a sud di Hanoi, e parliamo di un isolotto nei pressi della più estesa Cat ba. Un posto magnifico, si tratta di arrivarci ora.  C’è tempo prima per una mattina di scoperta della tutto sommato bella Hanoi, al netto del traffico assassino. Assaporo un bel tempietto su un piccolo lago situato proprio nel mezzo della città.
C’è tempo prima per una mattina di scoperta della tutto sommato bella Hanoi, al netto del traffico assassino. Assaporo un bel tempietto su un piccolo lago situato proprio nel mezzo della città.  il lago (meglio dire lo stagno) prende il nome di Hoam Kiem, che in vietnamita significa la bellezza di “Lago della spada restituita” ed allude ad una vittoria ottenuta contro gli invasori cinesi da un re locale, per intercessione pure di una tartaruga sacra , ora onorata in una bella scultura di giada, che viveva nel lago
il lago (meglio dire lo stagno) prende il nome di Hoam Kiem, che in vietnamita significa la bellezza di “Lago della spada restituita” ed allude ad una vittoria ottenuta contro gli invasori cinesi da un re locale, per intercessione pure di una tartaruga sacra , ora onorata in una bella scultura di giada, che viveva nel lago  Immaginare quella fetida pozza urbana popolata di tartarughe appare difficile oggi quando al massimo potrà essere popolata di ratti e colibatteri fecali appare improbabile oggi ma tant’è, il dato che appare, anche dalla successiva visita al museo archeologico è un altro: il popolo vietnamita, un tempo identificato nei progenitori Champa, ha una lunga storia di battaglie contro superpotenze invasori. Assai prima del colonialismo yankee, i vietnamiti hanno dovuto per secoli tenere a bada le mire espansionistiche del gigante cinese e pure di quello mongolo, riuscendo sempre egregiamente a far tenere il culo fuori dalla loro terra a pretenziosi conquistatori.
Immaginare quella fetida pozza urbana popolata di tartarughe appare difficile oggi quando al massimo potrà essere popolata di ratti e colibatteri fecali appare improbabile oggi ma tant’è, il dato che appare, anche dalla successiva visita al museo archeologico è un altro: il popolo vietnamita, un tempo identificato nei progenitori Champa, ha una lunga storia di battaglie contro superpotenze invasori. Assai prima del colonialismo yankee, i vietnamiti hanno dovuto per secoli tenere a bada le mire espansionistiche del gigante cinese e pure di quello mongolo, riuscendo sempre egregiamente a far tenere il culo fuori dalla loro terra a pretenziosi conquistatori.  La cultura Champa vanta in effetti tesori inestimabile valore artistico ma non altrettanti siti originari ove conservarli come la vicina Cambogia: i più belli sono andati perduti nel conflitto con gli americani a cui è riuscita l’impresa barbara di bombardare persino dei siti archeologici , si che le opere sono ora conservate nel bellissimo museo di storia
La cultura Champa vanta in effetti tesori inestimabile valore artistico ma non altrettanti siti originari ove conservarli come la vicina Cambogia: i più belli sono andati perduti nel conflitto con gli americani a cui è riuscita l’impresa barbara di bombardare persino dei siti archeologici , si che le opere sono ora conservate nel bellissimo museo di storia  La scena museale di Hanoi è sorprendentemente vasta e di livello, compendiando a fianco al già citato museo di storia anche un originale museo dedicato alla figura della donna nella cultura vietnamita
La scena museale di Hanoi è sorprendentemente vasta e di livello, compendiando a fianco al già citato museo di storia anche un originale museo dedicato alla figura della donna nella cultura vietnamita il plesso è tenuto e organizzato in misura davvero eccellente, con sezioni che spaziano dalla figura nella donna nel matrimonio passando per l’arte culinaria fino all’omaggio ad eroine locale come tale Chan Kin, una contadina di una minoranza del sud capace di accoppare in battaglia la bellezza di 155 nemici americani e persino un aereo da trasporto con la sua mitragliatrice.
il plesso è tenuto e organizzato in misura davvero eccellente, con sezioni che spaziano dalla figura nella donna nel matrimonio passando per l’arte culinaria fino all’omaggio ad eroine locale come tale Chan Kin, una contadina di una minoranza del sud capace di accoppare in battaglia la bellezza di 155 nemici americani e persino un aereo da trasporto con la sua mitragliatrice.
Ma ormai è ora di partire, rotta a sud verso il golfo del Tonchino che si appalesa dopo un paio di ore di bus Per me significa essere arrivato dall’altra parte, su un altro mare dopo essere partito dal golfo del Siam. Per chi mangia pane e geografia come me so soddisfazioni! Siamo nella celeberrima Halong Bay, divenuta nota recentemente in tutto il mondo per la “scoperta” degli scenari naturali con picchi calcarei che paiono spuntare come ghiaccioli verdi dal mare anche esso verde ma più chiaro. La prima tappa è Cat ba, che si manifesta subito magnifica
Per me significa essere arrivato dall’altra parte, su un altro mare dopo essere partito dal golfo del Siam. Per chi mangia pane e geografia come me so soddisfazioni! Siamo nella celeberrima Halong Bay, divenuta nota recentemente in tutto il mondo per la “scoperta” degli scenari naturali con picchi calcarei che paiono spuntare come ghiaccioli verdi dal mare anche esso verde ma più chiaro. La prima tappa è Cat ba, che si manifesta subito magnifica  eccezion fatta per il centro abitato principale irto di inspiegabili grattacieli e palazzacci, mentre tutto intorno pernla vasta superficie dell’isola regna una natura piuttosto incontaminata e lussuriosa. Ma non è questa la mia meta finale: devo arrivare a Monkey Island e quindi sciropparmi un’altra attaverdamento Marino dal secondario molo di Ben-Beo, ubicato giusto alla fine di un fiordo pervaso da una bellezza fuori dal comune come quello della baia di Han La
eccezion fatta per il centro abitato principale irto di inspiegabili grattacieli e palazzacci, mentre tutto intorno pernla vasta superficie dell’isola regna una natura piuttosto incontaminata e lussuriosa. Ma non è questa la mia meta finale: devo arrivare a Monkey Island e quindi sciropparmi un’altra attaverdamento Marino dal secondario molo di Ben-Beo, ubicato giusto alla fine di un fiordo pervaso da una bellezza fuori dal comune come quello della baia di Han La  fa buio e quindi molta della bellezza viene mangiata dalle tenebre e rimessa alla nostra immaginazione ma poco male: solcare acque magiche sul far della sera nel bel mezzo di un mare un tempo popolato da mercanti e pirati è un’emozione che riempie il cuore a noi tutti.
fa buio e quindi molta della bellezza viene mangiata dalle tenebre e rimessa alla nostra immaginazione ma poco male: solcare acque magiche sul far della sera nel bel mezzo di un mare un tempo popolato da mercanti e pirati è un’emozione che riempie il cuore a noi tutti.





 e a sorseggiare la Bia Hoi , una birretta light importata dai cecoslovacchi negli anni allucinanti del comunismo, che viene spillata direttamente per strada da venditori ambulanti a cifre ridicole
e a sorseggiare la Bia Hoi , una birretta light importata dai cecoslovacchi negli anni allucinanti del comunismo, che viene spillata direttamente per strada da venditori ambulanti a cifre ridicole 








 o immergetevi nel paesaggio di colline impenetrabili intervallata solo da risaie che assumono in questa stagione una tonalità di verde quasi psichedelico:
o immergetevi nel paesaggio di colline impenetrabili intervallata solo da risaie che assumono in questa stagione una tonalità di verde quasi psichedelico:  vicino in queste montagne molte minoranze etniche tra chi gli Akha e gli Hmong dalla storia tormentata. Giungerete alla Kuang si falls, dove potrete anche nuotare. È un posto che a chiamarlo Eden non gli si rende giustizia per quanto è bello
vicino in queste montagne molte minoranze etniche tra chi gli Akha e gli Hmong dalla storia tormentata. Giungerete alla Kuang si falls, dove potrete anche nuotare. È un posto che a chiamarlo Eden non gli si rende giustizia per quanto è bello



 Già, in un effetti Luang Prabang significa in laotiano proprio questo: “Immagine del regale Buddha” ed è un regno antichissimo incastonato in un fondovalle di una remota regione di monti altissimi, una città-stato dalla storia millenaria.
Già, in un effetti Luang Prabang significa in laotiano proprio questo: “Immagine del regale Buddha” ed è un regno antichissimo incastonato in un fondovalle di una remota regione di monti altissimi, una città-stato dalla storia millenaria.  Ripeto il nome del posto perché credo che, a meno che non siate forti in geografia, non vi dirà molto: Luang Prabang. Siamo nel Laos settentrionale, su una penisola disegnata dall’onnipresente Mekong che qui si incontra o meglio dire assorbe, fagocita dentro se un fiume minore, il Nam Kam.
Ripeto il nome del posto perché credo che, a meno che non siate forti in geografia, non vi dirà molto: Luang Prabang. Siamo nel Laos settentrionale, su una penisola disegnata dall’onnipresente Mekong che qui si incontra o meglio dire assorbe, fagocita dentro se un fiume minore, il Nam Kam.  In linea d’aria non siamo lontani come latitudine dal nord della Thailandia e dal Chang Mai, che disterà forse un 200 km, fatti però di montagne impenetrabili e strade tortuose. Chang Mai è assai pubblicizzata dalle agenzie turistiche thailandesi come una “romantica città d’arte” ma diciamo che in tal senso può giocarsela con una Luang Prabang come il Centro commerciale “Porte della Campania” se la vede con una Siena o una Verona. A proposito della città scaligera, capiterà nei miei diversi giorni di soggiorno qui una coincidenza francamente assai singolare ma ne parleremo magari più avanti: per adesso voglio continuare nell’introduzione alla bellissima Luang Prabang.
In linea d’aria non siamo lontani come latitudine dal nord della Thailandia e dal Chang Mai, che disterà forse un 200 km, fatti però di montagne impenetrabili e strade tortuose. Chang Mai è assai pubblicizzata dalle agenzie turistiche thailandesi come una “romantica città d’arte” ma diciamo che in tal senso può giocarsela con una Luang Prabang come il Centro commerciale “Porte della Campania” se la vede con una Siena o una Verona. A proposito della città scaligera, capiterà nei miei diversi giorni di soggiorno qui una coincidenza francamente assai singolare ma ne parleremo magari più avanti: per adesso voglio continuare nell’introduzione alla bellissima Luang Prabang. 

 In mezzo, il resto della giornata ci penserà la storia millenaria di Luang Prabang a riempirvelo. Nata come regno in un’epoca in cui la storia si fonde inevitabilmente con la leggenda, Luang Prabang pare debba la sua fondazione ad un essere mitologico asessuato dal viso rossastro ed il corpo filamentoso. chiamato Phunheu Nhaheu, e raffigurato sopra i frontoni di molti templi. La prima fase della sua storia parla di Re dalle sembianze di scimmie e cervi magici e si interseca con le vicende del popolo tibetano e della zona himalahiana, che in questi monti trova la sua estrema propaggine meridionale. Luang Prabang si è poi conservata come , regno a se stante nelle varie fasi storiche, giungendo all’apice verso fine ottocento con un re tuttora venerato dalla personalità ascetica e meditativa, tale Viseoun. Anche la Francia che colonizzava tutta o quasi l’Indocina francese garantii una sua indipendenza al Regno di Luang Prabang e persino la successiva terribile occupazione giapponese nel conflitto mondiale fece salvi i templi e la storia della città. Un regno ascetico in Indocina incastrato tra le montagne e poggiato su due fiumi già di suo fa sognare la mente e scatena la fantasia: le cronache dei viaggiatori francesi di inizio secolo descrivono con vibrante passione questo regno remoto e mistico in cui chi non volesse avere più niente a che fare con la Francia veniva a trovare rifugio . Figurarsi che ancora nel 1930 ci voleva più tempo a risalire il fiume da Saigon a Luang Prabang che dalla stessa Saigon a Marsiglia . La presenza francese è infatti molto ben testimoniata dalle tante case perfettamente conservate in stile coloniale. Lo stesso istituto di cultura francese è un gioiello in tal senso.
In mezzo, il resto della giornata ci penserà la storia millenaria di Luang Prabang a riempirvelo. Nata come regno in un’epoca in cui la storia si fonde inevitabilmente con la leggenda, Luang Prabang pare debba la sua fondazione ad un essere mitologico asessuato dal viso rossastro ed il corpo filamentoso. chiamato Phunheu Nhaheu, e raffigurato sopra i frontoni di molti templi. La prima fase della sua storia parla di Re dalle sembianze di scimmie e cervi magici e si interseca con le vicende del popolo tibetano e della zona himalahiana, che in questi monti trova la sua estrema propaggine meridionale. Luang Prabang si è poi conservata come , regno a se stante nelle varie fasi storiche, giungendo all’apice verso fine ottocento con un re tuttora venerato dalla personalità ascetica e meditativa, tale Viseoun. Anche la Francia che colonizzava tutta o quasi l’Indocina francese garantii una sua indipendenza al Regno di Luang Prabang e persino la successiva terribile occupazione giapponese nel conflitto mondiale fece salvi i templi e la storia della città. Un regno ascetico in Indocina incastrato tra le montagne e poggiato su due fiumi già di suo fa sognare la mente e scatena la fantasia: le cronache dei viaggiatori francesi di inizio secolo descrivono con vibrante passione questo regno remoto e mistico in cui chi non volesse avere più niente a che fare con la Francia veniva a trovare rifugio . Figurarsi che ancora nel 1930 ci voleva più tempo a risalire il fiume da Saigon a Luang Prabang che dalla stessa Saigon a Marsiglia . La presenza francese è infatti molto ben testimoniata dalle tante case perfettamente conservate in stile coloniale. Lo stesso istituto di cultura francese è un gioiello in tal senso.



 l’impatto ormai è inevitabile: memore della esperienza del giorno prima (quando per schivare i rami ci siamo sbilanciati tutti verso un lato facendo rovesciare il kayak) , prendo a urlare a tutti di stare a terra e non buttarsi in un lato. Non saprei dire se mi abbiamo ascoltato o meno, fatto sta che con molta buona sorte evitamo un ribaltamento della barca che davvero avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Una tempesta di rami e rovi ci passa sopra le teste come il fuoco di una mitragliatrice, ci graffia braccia, schiena, gambe. Siamo fortunati da non sbattere contro masso o ostacolo rigido che a quella velocità sarebbe stato bruttarello, poi un ragazzino locale davvero con un gesto allaTarzan prende con le gambe in orizzontale a fare al volo leva contro un tronco allontanando di quel mezzo metro la barca per permetterci di passare oltre. Siamo passati, qualche graffio per tutti ma nulla più. Ora peró qualcuno dovrà venire a prenderci, perché siamo ancora alla deriva: con una difficile manovra una seconda piroga ci aggancia e ci fa accostare in un punto dell’isolotto risparmiato dalla corrente. Trasbordiamo e siamo in salvo. Questa davvero me la ricordo finché campo
l’impatto ormai è inevitabile: memore della esperienza del giorno prima (quando per schivare i rami ci siamo sbilanciati tutti verso un lato facendo rovesciare il kayak) , prendo a urlare a tutti di stare a terra e non buttarsi in un lato. Non saprei dire se mi abbiamo ascoltato o meno, fatto sta che con molta buona sorte evitamo un ribaltamento della barca che davvero avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Una tempesta di rami e rovi ci passa sopra le teste come il fuoco di una mitragliatrice, ci graffia braccia, schiena, gambe. Siamo fortunati da non sbattere contro masso o ostacolo rigido che a quella velocità sarebbe stato bruttarello, poi un ragazzino locale davvero con un gesto allaTarzan prende con le gambe in orizzontale a fare al volo leva contro un tronco allontanando di quel mezzo metro la barca per permetterci di passare oltre. Siamo passati, qualche graffio per tutti ma nulla più. Ora peró qualcuno dovrà venire a prenderci, perché siamo ancora alla deriva: con una difficile manovra una seconda piroga ci aggancia e ci fa accostare in un punto dell’isolotto risparmiato dalla corrente. Trasbordiamo e siamo in salvo. Questa davvero me la ricordo finché campo
 Vorrei arrisicarmi in qualche modo ma è piuttosto difficile la visita nella stagione delle piogge per vie dei torrenti rigonfi d’acqua. Mi limito così a prendere un banale aereo per volare a nord del Laos verso una città che si annuncia bellissima chiamata Luang Prabang. In verità avrei un mio codice interno per cui dovrei giungere alla meta finale via terra: con l’aereo so’boni tutti e mi ammazza il gusto. Ma un piccolo volo interno al Laos con la compagnia di bandiera locale possiede quel margine di brivido e avventura utile a indorare la pillola.
Vorrei arrisicarmi in qualche modo ma è piuttosto difficile la visita nella stagione delle piogge per vie dei torrenti rigonfi d’acqua. Mi limito così a prendere un banale aereo per volare a nord del Laos verso una città che si annuncia bellissima chiamata Luang Prabang. In verità avrei un mio codice interno per cui dovrei giungere alla meta finale via terra: con l’aereo so’boni tutti e mi ammazza il gusto. Ma un piccolo volo interno al Laos con la compagnia di bandiera locale possiede quel margine di brivido e avventura utile a indorare la pillola. 


 in realtà poco più che un gettito di sabbia e fango compatto che il Mekong lascia per strada nella sua corsa verso sud, uno sputo solidificato che il Grande Fiume potrebbe ringhiottire con la facilità con cui un Polifemo si nutre dei compagni di Ulisse prima dell’accecamento. Il riferimento all’Odissea non è speso male, perché il contesto naturale è davvero “post-omerico”, mi si consenta il brevetto di questo affascinante concetto che mi piace proprio assai. Questa è la terra mitica dei mangiatori di loto, i fiori che danno l’oblio, sempre che di terra possa parlarsi atteso che si ha la sensazione di essere su qualche zattera semovente gettata nel Mekong.
in realtà poco più che un gettito di sabbia e fango compatto che il Mekong lascia per strada nella sua corsa verso sud, uno sputo solidificato che il Grande Fiume potrebbe ringhiottire con la facilità con cui un Polifemo si nutre dei compagni di Ulisse prima dell’accecamento. Il riferimento all’Odissea non è speso male, perché il contesto naturale è davvero “post-omerico”, mi si consenta il brevetto di questo affascinante concetto che mi piace proprio assai. Questa è la terra mitica dei mangiatori di loto, i fiori che danno l’oblio, sempre che di terra possa parlarsi atteso che si ha la sensazione di essere su qualche zattera semovente gettata nel Mekong.  Qui il fiume arriva a misurare da una sponda all’altra la bellezza di 14 km (per capirci più del braccio di mare che separa Capri da Sorrento) e, prima di travolgere la Cambogia, si contorce un po’ nervosamente nel suo letto qui, disseminandolo di macchie alberate. La denominazione “4000 isole sul Mekong” che pare sulle prime un iperbole nel neonato stile “post-omerico” è invece tutto sommato realistico, a condizione di poter chiamare isole anche le più piccole striscie di sabbia emergenti dal gorgo. Don Det, insieme con Don Khong è una delle relativamente più estese,
Qui il fiume arriva a misurare da una sponda all’altra la bellezza di 14 km (per capirci più del braccio di mare che separa Capri da Sorrento) e, prima di travolgere la Cambogia, si contorce un po’ nervosamente nel suo letto qui, disseminandolo di macchie alberate. La denominazione “4000 isole sul Mekong” che pare sulle prime un iperbole nel neonato stile “post-omerico” è invece tutto sommato realistico, a condizione di poter chiamare isole anche le più piccole striscie di sabbia emergenti dal gorgo. Don Det, insieme con Don Khong è una delle relativamente più estese,  dove è possibile alla river people una vita di pesca e coltivazione del riso negli anfratti di terra non troppo sommersi
dove è possibile alla river people una vita di pesca e coltivazione del riso negli anfratti di terra non troppo sommersi Due delle cose che meno amo al mondo sono qui completamente assenti, parlo del cemento e dell’asfalto, mentre due sono le sole strade che esistono a Don Det e non sono certo intitolate ai Mazzini e Cavour locali, giacche si chiamano figuratevi Sunrise strip per quella che corre lungo la costa est e che assiste dunque all’alba, e poi sta Sunset strip sulla costa opposta, quella che vede il tramonto. Tra l’Alba e il Tramonto o viceversa (sono concetti arrotolati uno nell’altro da ste parti), vive entro palafitte di legno una comunità a suo modo variegata e unica, dove agli indigeni, fermi davvero ad un mondo di cento anni fa, si è andata ad unire e a ben amalgamare una umanità di occidentali in fuga dal proprio mondo, dai ritmi che non lasciano scampo alle emozioni e dalle mille responsabilità
Due delle cose che meno amo al mondo sono qui completamente assenti, parlo del cemento e dell’asfalto, mentre due sono le sole strade che esistono a Don Det e non sono certo intitolate ai Mazzini e Cavour locali, giacche si chiamano figuratevi Sunrise strip per quella che corre lungo la costa est e che assiste dunque all’alba, e poi sta Sunset strip sulla costa opposta, quella che vede il tramonto. Tra l’Alba e il Tramonto o viceversa (sono concetti arrotolati uno nell’altro da ste parti), vive entro palafitte di legno una comunità a suo modo variegata e unica, dove agli indigeni, fermi davvero ad un mondo di cento anni fa, si è andata ad unire e a ben amalgamare una umanità di occidentali in fuga dal proprio mondo, dai ritmi che non lasciano scampo alle emozioni e dalle mille responsabilità  per ricostruirne una su basi più gracili come questi sedimenti sabbiosi ma più felice e fissata in belle massime di vita scolpite in pannelli in legno che pendono da tutti i soffitti delle casupole, in una singolare gara a chi espone la sentenza più originale
per ricostruirne una su basi più gracili come questi sedimenti sabbiosi ma più felice e fissata in belle massime di vita scolpite in pannelli in legno che pendono da tutti i soffitti delle casupole, in una singolare gara a chi espone la sentenza più originale 

 L’isola non vanta grosse tradizioni culinarie, eccezion fatta per la pasticceria di alto livello: sulle tavole di ogni locale di Don Det potrete assaggiare, se proprio ne avete voglia, i cd “happy cakes”, specialità della casa che compendia un impasto di pan di Spagna, mango, cioccolato e…..marjuana. La versione 2.0 dei mitologici fiori di loto insomma . A giudicare dagli effetti che noto sui suoi degustatori mi pare di capire sia buono. Ma come occupa poi la scanzonata gente di Don Det il suo tempo nell’arco della giornata? Partecipando per esempio alle magnifiche escursioni in kayak sulle rapide del Mekong organizzati da Mr. Mu (che non sta per mister Muscolo dal momento che ha una panza che io a confronto sono un pallanuotista).
L’isola non vanta grosse tradizioni culinarie, eccezion fatta per la pasticceria di alto livello: sulle tavole di ogni locale di Don Det potrete assaggiare, se proprio ne avete voglia, i cd “happy cakes”, specialità della casa che compendia un impasto di pan di Spagna, mango, cioccolato e…..marjuana. La versione 2.0 dei mitologici fiori di loto insomma . A giudicare dagli effetti che noto sui suoi degustatori mi pare di capire sia buono. Ma come occupa poi la scanzonata gente di Don Det il suo tempo nell’arco della giornata? Partecipando per esempio alle magnifiche escursioni in kayak sulle rapide del Mekong organizzati da Mr. Mu (che non sta per mister Muscolo dal momento che ha una panza che io a confronto sono un pallanuotista).  Il fiume qui si contorce in una serie di rapide e cascate dalla forza e gittata impressionante, inoltre più a valle, proprio nello spazio d’acqua dinanzi alla Cambogia vive uno sparuto gruppo di delfini di acqua dolce, il cui avvistamento pare garantito con un po’ di pazienza e occhio lungo. Io faccio squadra in kayak con il mitico Jason, un lungagnone australiano che pare uscito dal grande Lebowsky, le cui enormi potenzialità appaiono subito chiare nel contemplarlo fare colazione a whisky & cigarettes….
Il fiume qui si contorce in una serie di rapide e cascate dalla forza e gittata impressionante, inoltre più a valle, proprio nello spazio d’acqua dinanzi alla Cambogia vive uno sparuto gruppo di delfini di acqua dolce, il cui avvistamento pare garantito con un po’ di pazienza e occhio lungo. Io faccio squadra in kayak con il mitico Jason, un lungagnone australiano che pare uscito dal grande Lebowsky, le cui enormi potenzialità appaiono subito chiare nel contemplarlo fare colazione a whisky & cigarettes….
 nella sua forma un po’ tozza e una testona deforme che francamente mi ha ricordato la forma di un pisello. Per capirci vi mostro una foto di repertorio non certo scattata da me
nella sua forma un po’ tozza e una testona deforme che francamente mi ha ricordato la forma di un pisello. Per capirci vi mostro una foto di repertorio non certo scattata da me  vi e poi tempo per una faticosa risalita in kayak in territorio laotiano fino ad un’altra roboante cascata, la cd Khone Papheng in cui il Mekong davvero si mostra con la potenza di una divinità
vi e poi tempo per una faticosa risalita in kayak in territorio laotiano fino ad un’altra roboante cascata, la cd Khone Papheng in cui il Mekong davvero si mostra con la potenza di una divinità  Secondo me gliela tagliano ma sento dire che si tratti di una razza locale: il fatto è che lo sento dire ai consumatori dei pan di Spagna bagnati alla maria che certo non paiono dei campioni di attendibilità.
Secondo me gliela tagliano ma sento dire che si tratti di una razza locale: il fatto è che lo sento dire ai consumatori dei pan di Spagna bagnati alla maria che certo non paiono dei campioni di attendibilità.
 Gli hippie o freak volevano cambiare il mondo per provare a riscriverlo con poche e semplici ingenue regole di vita. Ad un certo punto della storia erano diventati tanti e gonfiarono le università e le piazze ma non era ovviamente che una stagione fugace. Furono presto sconfitti e dalle città arretrarono alle campagne, poi a posti sempre più remoti dove mettere su una vita rilassata e basata su poche convenzioni. Le 4000 isole sul Mekong restano la loro inespugnabile Stalingrado, con la loro ubicazione così impervia in un buco del culo dell’Atlante geografico e il Mekong gigante buono a proteggerli con le sue rapide e cascate dal Progresso, altro gigante a volte buono a volte no. È un luogo magico e crepuscolare che scomparirà da un giorno all’altro come queste isole che prima o poi il Grande Fiume inghiottirà . Sta da capire insomma quale dei due Giganti farà prima in una mitologica contesa. Per ora le 4000 isole vivono e sono la realizzazione di una vera e propria utopia, nel senso quasi scientifico del termine (sarebbe più corretto parlare di “ectopia” ma vabbè): queste isole sono la declinazione freakkettona del regno di Utopia
Gli hippie o freak volevano cambiare il mondo per provare a riscriverlo con poche e semplici ingenue regole di vita. Ad un certo punto della storia erano diventati tanti e gonfiarono le università e le piazze ma non era ovviamente che una stagione fugace. Furono presto sconfitti e dalle città arretrarono alle campagne, poi a posti sempre più remoti dove mettere su una vita rilassata e basata su poche convenzioni. Le 4000 isole sul Mekong restano la loro inespugnabile Stalingrado, con la loro ubicazione così impervia in un buco del culo dell’Atlante geografico e il Mekong gigante buono a proteggerli con le sue rapide e cascate dal Progresso, altro gigante a volte buono a volte no. È un luogo magico e crepuscolare che scomparirà da un giorno all’altro come queste isole che prima o poi il Grande Fiume inghiottirà . Sta da capire insomma quale dei due Giganti farà prima in una mitologica contesa. Per ora le 4000 isole vivono e sono la realizzazione di una vera e propria utopia, nel senso quasi scientifico del termine (sarebbe più corretto parlare di “ectopia” ma vabbè): queste isole sono la declinazione freakkettona del regno di Utopia 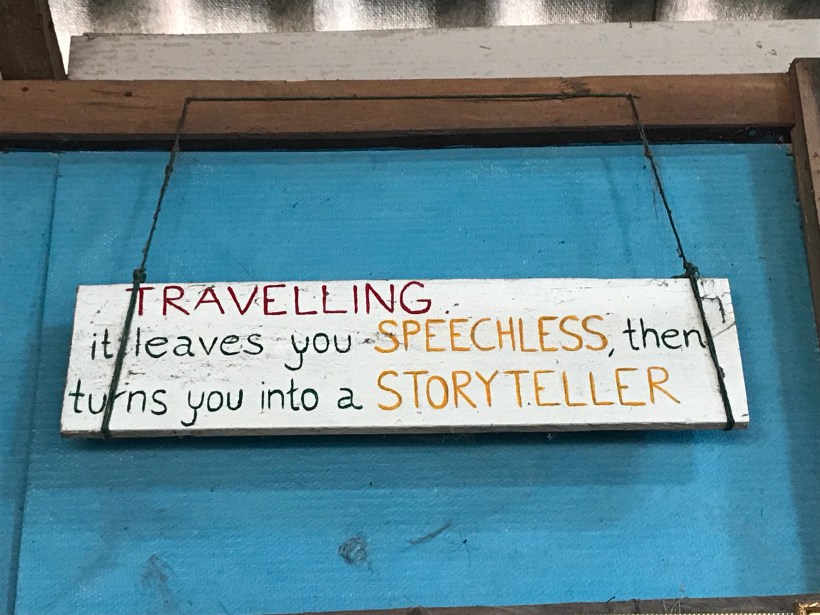

 Per non parlare di alberghi e ristoranti: il delizioso Amok è diventato una sorta di catena di ristorazione dove il pesce del lago Tonle Sap avvolto nel tamarindo ha la stessa freschezza di un cheeseburger da Macdonald, ovunque poi albergoni e resort per ogni tasca ed esigenza. Quasi inevitabile che finisca così, vista la massa di gente interessata a visitare una meraviglia come l’Angkor What e sta comunque da aggiungere che Siem Reap ha saputo reinventarsi come capitale turistica della intera area, pur sacrificando la sua vecchia aurea da posto hippie sull’altare del marketing turistico e degli enormi profitti. Detto questo, forse possiamo passare oltre un posto che a molto di voi dirà poco o nulla come Siem Reap e guardare al motivo prevalente di una visita in questa parte di mondo ovvero l’Angkor Wat.
Per non parlare di alberghi e ristoranti: il delizioso Amok è diventato una sorta di catena di ristorazione dove il pesce del lago Tonle Sap avvolto nel tamarindo ha la stessa freschezza di un cheeseburger da Macdonald, ovunque poi albergoni e resort per ogni tasca ed esigenza. Quasi inevitabile che finisca così, vista la massa di gente interessata a visitare una meraviglia come l’Angkor What e sta comunque da aggiungere che Siem Reap ha saputo reinventarsi come capitale turistica della intera area, pur sacrificando la sua vecchia aurea da posto hippie sull’altare del marketing turistico e degli enormi profitti. Detto questo, forse possiamo passare oltre un posto che a molto di voi dirà poco o nulla come Siem Reap e guardare al motivo prevalente di una visita in questa parte di mondo ovvero l’Angkor Wat.  Che dire mai di un posto del genere? Non saprei neanche da come cominciare. Diciamo che non vi è foto, video o altro strumento di riproduzione tecnologica che ne può rendere la magnificenza o la bellezza. Si tratta del sito archeologico più vasto al mondo, esteso per decine di km quadrati, una delle edificazioni più ispirate che la mente umana abbia mai concepito.
Che dire mai di un posto del genere? Non saprei neanche da come cominciare. Diciamo che non vi è foto, video o altro strumento di riproduzione tecnologica che ne può rendere la magnificenza o la bellezza. Si tratta del sito archeologico più vasto al mondo, esteso per decine di km quadrati, una delle edificazioni più ispirate che la mente umana abbia mai concepito. 

 La denominazione “Angkor Wat”, con cui è universalmente conosciuta è tra l’altro riferibile in verità solo ad uno, il più maestoso degli oltre 4.500 (si, proprio così quattromilacinquecento) templi qui edificati, alcuni dei quali ammantati in una fitta giungla che ne finisce per amplificare la bellezza
La denominazione “Angkor Wat”, con cui è universalmente conosciuta è tra l’altro riferibile in verità solo ad uno, il più maestoso degli oltre 4.500 (si, proprio così quattromilacinquecento) templi qui edificati, alcuni dei quali ammantati in una fitta giungla che ne finisce per amplificare la bellezza 
 Tanta bellezza finisce per disorientare e almeno a me è capitato di cercare una via di interpretazione nella visita più lateral, che partisse dai dettagli per salire alle stelle, come ad esempio l’osservazione dei centinaia di migliaia di bassorilievi (ancora una volta il numero non è foriero di alcuna esagerazione) che ricostruiscono le vicende della storia khmer e dell’ascesa dei loro re, su tutti Javavarman II, nome che gli appassionati di cacce al tesoro palillesche faranno bene a ricordare….
Tanta bellezza finisce per disorientare e almeno a me è capitato di cercare una via di interpretazione nella visita più lateral, che partisse dai dettagli per salire alle stelle, come ad esempio l’osservazione dei centinaia di migliaia di bassorilievi (ancora una volta il numero non è foriero di alcuna esagerazione) che ricostruiscono le vicende della storia khmer e dell’ascesa dei loro re, su tutti Javavarman II, nome che gli appassionati di cacce al tesoro palillesche faranno bene a ricordare…. Personalmente non riesco a credere, come altre religioni fanno, che noi umani siamo destinati a reincarnarci in altre essenze e a vivere altre vite; per quanto mi riguarda ci è stata data solo una vita: non fatela trascorrere senza aver mai visto l’Angkor Wat
Personalmente non riesco a credere, come altre religioni fanno, che noi umani siamo destinati a reincarnarci in altre essenze e a vivere altre vite; per quanto mi riguarda ci è stata data solo una vita: non fatela trascorrere senza aver mai visto l’Angkor Wat


 una città galleggiante che porta in qualche modo le stigmate del progresso nei suoi aspetti deteriori, ad esempio l’inquinamento presente in quintali di plastica galleggiante e un’acqua putrida in cui incredibilmente i locali si lavano e fanno il bagno. La successiva fase di navigazione si apre ad uno scenario diverso, più tipicamente fluviale su ampi canali, siamo ormai sul lago Tonle Sap, culla della civiltà khmer, pietra angolare liquida di questa cultura che da queste acque seppe ricavare prosperità e fulgore. Proprio sulla parete d’entrata dell’Angkor Wat è scolpito un lunghissimo bassorilievo che narra di una battaglia cruciale tra i khmer e i loro eterni rivali Cham (gli attuali vietnamiti) con esito favorevole ai primi
una città galleggiante che porta in qualche modo le stigmate del progresso nei suoi aspetti deteriori, ad esempio l’inquinamento presente in quintali di plastica galleggiante e un’acqua putrida in cui incredibilmente i locali si lavano e fanno il bagno. La successiva fase di navigazione si apre ad uno scenario diverso, più tipicamente fluviale su ampi canali, siamo ormai sul lago Tonle Sap, culla della civiltà khmer, pietra angolare liquida di questa cultura che da queste acque seppe ricavare prosperità e fulgore. Proprio sulla parete d’entrata dell’Angkor Wat è scolpito un lunghissimo bassorilievo che narra di una battaglia cruciale tra i khmer e i loro eterni rivali Cham (gli attuali vietnamiti) con esito favorevole ai primi  ma di questo parleremo semmai domani. Schivato che è il rischio dei rami fendenti, sul battello possiamo rilassarci e salire sul tetto panoramico
ma di questo parleremo semmai domani. Schivato che è il rischio dei rami fendenti, sul battello possiamo rilassarci e salire sul tetto panoramico  ci resta ancora tempo per l’attraversamento della palude in cui ha sede la eccezionale riserva avio-faunistica del Prek Toal
ci resta ancora tempo per l’attraversamento della palude in cui ha sede la eccezionale riserva avio-faunistica del Prek Toal un paesaggio forse un po’ spettrale ma davvero un paradiso per gli appassionati di birdwatching che qui possono avvistare specie ormai quasi estinte come il mitologico Ibis gigante o l’avvoltoio testarossa. Giungiamo a destinazione dopo circa 9 ore, in un ennesimo villaggio galleggiante alle porte di Siem Reap, la capitale turistica della Cambogia per la sua vicinanza ai templi dell’Angkor Wat. Un bellissimo viaggio in battello, e domani si visita una delle sette meraviglie del mondo, l’Angkor Wat. Non male, direi
un paesaggio forse un po’ spettrale ma davvero un paradiso per gli appassionati di birdwatching che qui possono avvistare specie ormai quasi estinte come il mitologico Ibis gigante o l’avvoltoio testarossa. Giungiamo a destinazione dopo circa 9 ore, in un ennesimo villaggio galleggiante alle porte di Siem Reap, la capitale turistica della Cambogia per la sua vicinanza ai templi dell’Angkor Wat. Un bellissimo viaggio in battello, e domani si visita una delle sette meraviglie del mondo, l’Angkor Wat. Non male, direi

 Il punto di rottura tra una dimensione vacanziera e il viaggio è dato da un anonimo paesone posto alla bisettrice di due strade e dal nome uno e trino, tale Pong Nam Ron, dove lascio il pulmino che sale da Koh Chang per prendere la strada che taglia verso est verso i monti oltre i quali è la Cambogia. L’autista, che ha già dimostrato ampiamente di essere una capra per altri motivi, fatica oltremodo a capire perché mai debba scendere li, poi mi scarica nel bel mezzo di un mercato di frutta, dove gli avventori paiono essere assai poco avvezzi alla presenza di un “farang”, termine con cui in Thailandia chiamano gli occidentali. Un monaco buddista piuttosto malandato si fa gestore di una trattativa per montare sul retro di una carretta, che però mi lascerà pochi km dopo in prossimità della casa dell’autista:’qui una venditrice di frutta con estrema gentilezza mi fa montare su una camionetta gremita di contadini di ritorno ai campi dalla città con un numero impressionate di vettovaglie al seguito
Il punto di rottura tra una dimensione vacanziera e il viaggio è dato da un anonimo paesone posto alla bisettrice di due strade e dal nome uno e trino, tale Pong Nam Ron, dove lascio il pulmino che sale da Koh Chang per prendere la strada che taglia verso est verso i monti oltre i quali è la Cambogia. L’autista, che ha già dimostrato ampiamente di essere una capra per altri motivi, fatica oltremodo a capire perché mai debba scendere li, poi mi scarica nel bel mezzo di un mercato di frutta, dove gli avventori paiono essere assai poco avvezzi alla presenza di un “farang”, termine con cui in Thailandia chiamano gli occidentali. Un monaco buddista piuttosto malandato si fa gestore di una trattativa per montare sul retro di una carretta, che però mi lascerà pochi km dopo in prossimità della casa dell’autista:’qui una venditrice di frutta con estrema gentilezza mi fa montare su una camionetta gremita di contadini di ritorno ai campi dalla città con un numero impressionate di vettovaglie al seguito Così si sale fino al valico di frontiera di Ban Pakard, nella regione montuosa della catena dei cd Monti Cardamomi: queste belle cime ammantate di verde e di banani tanto da sembrare in alcuni punti il Kilimangiaro o il Ruwenzori nascondono nelle loro interiora due cose, una bella e una brutta: quella bella è costituita dalle preziose gemme di zaffiro che qui, specie sul versante cambogiano, vengono estratte in gran quantità e vendute grezze; la cosa brutta che salta invece fuori sempre dal sottosuolo sono le numerose mine antiuomo situate lungo il confine e risalenti all’illuminato, si fa per dire, regno dei khmer rossi degli anni ’70, che non volendosi far mancare alcunché nella lista delle atrocità da perpetrate al proprio stesso popolo, disseminarono il terreno di ordigni di fabbricazione udite udite in gran parte italiana e che ancora oggi mietono vittime tra la povera popolazione. Il valico di frontiera ubicato su queste montagne è quanto di più rilassato e sonnacchioso possa sperare di trovare chi ha qualcosa da nascondere: davvero inimmaginabile prima di vederla la scena dei doganieri cambogiani che letteralmente dormono nella guardiola, non so se perché pagati troppo poco e costretti magari ad altri estenuanti lavori notturni o forse perché proprio pagati per dormire e chiudere un occhio o meglio tutti e due su chi abbia voglia di contrabbandare gemme dalla Cambogia alla Thailandia per destinarle al mercato occidentale.
Così si sale fino al valico di frontiera di Ban Pakard, nella regione montuosa della catena dei cd Monti Cardamomi: queste belle cime ammantate di verde e di banani tanto da sembrare in alcuni punti il Kilimangiaro o il Ruwenzori nascondono nelle loro interiora due cose, una bella e una brutta: quella bella è costituita dalle preziose gemme di zaffiro che qui, specie sul versante cambogiano, vengono estratte in gran quantità e vendute grezze; la cosa brutta che salta invece fuori sempre dal sottosuolo sono le numerose mine antiuomo situate lungo il confine e risalenti all’illuminato, si fa per dire, regno dei khmer rossi degli anni ’70, che non volendosi far mancare alcunché nella lista delle atrocità da perpetrate al proprio stesso popolo, disseminarono il terreno di ordigni di fabbricazione udite udite in gran parte italiana e che ancora oggi mietono vittime tra la povera popolazione. Il valico di frontiera ubicato su queste montagne è quanto di più rilassato e sonnacchioso possa sperare di trovare chi ha qualcosa da nascondere: davvero inimmaginabile prima di vederla la scena dei doganieri cambogiani che letteralmente dormono nella guardiola, non so se perché pagati troppo poco e costretti magari ad altri estenuanti lavori notturni o forse perché proprio pagati per dormire e chiudere un occhio o meglio tutti e due su chi abbia voglia di contrabbandare gemme dalla Cambogia alla Thailandia per destinarle al mercato occidentale.  Interrotta dunque per mia iniziativa la fase rem dei brillanti quanto narcolettici Rambo cambogiani, rimedio il visto senza il quale non potrei poi lasciare il paese nel quale incredibilmente sarei potuto entrare senza alcun controllo!! Sono ora sul versante cambogiano in una città chiamata Pailin, un tempo prima capitale della Cambogia, circostanza che ora nessuno pare ricordare: per lo più ha l’aria squallida delle città di confine infestate da gente che vivacchia di traffici piccoli e grandi ap di qua e al di là della frontiera; insomma un posto poco ameno da cui partire alla spicciolata. La mia destinazione è un posto dal nome che pare un giochetto porno all’orientale, tale Battambang dove arrivo due ore dopo. Con un po’ troppa enfasi la Lonely Planet la definisce “perla coloniale” per via delle tutto sommate ben conservate dimore d’epoca, allorquando la città era sede del governatorato francese
Interrotta dunque per mia iniziativa la fase rem dei brillanti quanto narcolettici Rambo cambogiani, rimedio il visto senza il quale non potrei poi lasciare il paese nel quale incredibilmente sarei potuto entrare senza alcun controllo!! Sono ora sul versante cambogiano in una città chiamata Pailin, un tempo prima capitale della Cambogia, circostanza che ora nessuno pare ricordare: per lo più ha l’aria squallida delle città di confine infestate da gente che vivacchia di traffici piccoli e grandi ap di qua e al di là della frontiera; insomma un posto poco ameno da cui partire alla spicciolata. La mia destinazione è un posto dal nome che pare un giochetto porno all’orientale, tale Battambang dove arrivo due ore dopo. Con un po’ troppa enfasi la Lonely Planet la definisce “perla coloniale” per via delle tutto sommate ben conservate dimore d’epoca, allorquando la città era sede del governatorato francese  Per il resto la città ha un aspetto tutto sommato anonimo e funge da base di partenza per escursioni nella zona circostante: ad una di esse mi destino di buon grado anche io dopo aver trovato alloggio in una gradevole struttura a gestione familiare, anch’essa in stile coloniale
Per il resto la città ha un aspetto tutto sommato anonimo e funge da base di partenza per escursioni nella zona circostante: ad una di esse mi destino di buon grado anche io dopo aver trovato alloggio in una gradevole struttura a gestione familiare, anch’essa in stile coloniale  la gita prevede una visita ad un tempio ubicato una decina di km fuori città, da raggiungere con uno dei mezzi di trasporto prevalenti nella babele automobilistica cambogiana, un risciò a motore condotto da un simpatico locale
la gita prevede una visita ad un tempio ubicato una decina di km fuori città, da raggiungere con uno dei mezzi di trasporto prevalenti nella babele automobilistica cambogiana, un risciò a motore condotto da un simpatico locale 
 Pare che i giustizieri traessero ispirazione dai bassorilievi presenti sui templi di Ankgor, dove sono raffigurate torture e riti sacrificali umani di una cultura di mille anni prima. ancora oggi nella grotta sono conservati decine di teschi la cui identificazione non potrà mai essere resa
Pare che i giustizieri traessero ispirazione dai bassorilievi presenti sui templi di Ankgor, dove sono raffigurate torture e riti sacrificali umani di una cultura di mille anni prima. ancora oggi nella grotta sono conservati decine di teschi la cui identificazione non potrà mai essere resa


 Appena più in basso una incredibile altra grotta, da cui sul far della sera fuoriesce un numero impressionante di pipistrelli che forma un fiume nel cielo tale da eclissare il sole. C’è chi dice che siano 4 milioni ma non credo sia facile farne una conta
Appena più in basso una incredibile altra grotta, da cui sul far della sera fuoriesce un numero impressionante di pipistrelli che forma un fiume nel cielo tale da eclissare il sole. C’è chi dice che siano 4 milioni ma non credo sia facile farne una conta 

 , dove avviene un incontro sorprendente: mentre mi intrattengo con delle trote che mi ricordavano le caprette di Villa jovis nel loro aver maturato una abitudine alla presenza umana e nell’attendere da essa offerte di cibo, appare proprio sotto lo scoglio sul quale sono appollaiato una tartaruga di fiume di dimensioni considerevoli
, dove avviene un incontro sorprendente: mentre mi intrattengo con delle trote che mi ricordavano le caprette di Villa jovis nel loro aver maturato una abitudine alla presenza umana e nell’attendere da essa offerte di cibo, appare proprio sotto lo scoglio sul quale sono appollaiato una tartaruga di fiume di dimensioni considerevoli
 e nel cui “sagrato” è possibile anche nuotare, se avete lo stomaco di attraversare prima la corrente attaccati ad una malferma corda nei pressi di una rapida e inerpicarvi poi su una roccia scivolosissima.
e nel cui “sagrato” è possibile anche nuotare, se avete lo stomaco di attraversare prima la corrente attaccati ad una malferma corda nei pressi di una rapida e inerpicarvi poi su una roccia scivolosissima.  Ovviamente non riesco a resistere proprio alla tentazione…..
Ovviamente non riesco a resistere proprio alla tentazione….. La corrente e certi “colli di mare” belli grossi ci si mettono di impegno a guastarmi la festa ma alla fine approdo, sentendomi un po’ come il mitico Gennarino Carunchio in ” Travolti da un insolito destino…etc” alla ricerca della sua Mariangela Melato “bottana industriale “.
La corrente e certi “colli di mare” belli grossi ci si mettono di impegno a guastarmi la festa ma alla fine approdo, sentendomi un po’ come il mitico Gennarino Carunchio in ” Travolti da un insolito destino…etc” alla ricerca della sua Mariangela Melato “bottana industriale “.  Scherzi a parte, il paesaggio è davvero paradisiaco
Scherzi a parte, il paesaggio è davvero paradisiaco 