L’addio a Don Det e alle 4000 isole sul Mekong mi riempie di commozione : so già che è uno di quei posti che porterò sempre nel cuore ma ove non tornerò mai più, anche perché farlo significa storpiare il ricordo e l’unicità di emozioni che non tornano uguali. E poi questo è uno di quei posti crepuscolari, destinati irrimediabilmente a mutare, a entrare in un mondo di convenzioni da cui finora sono stati in gran parte fuori La mattina sul molo o su qualcosa che vi somiglia, ci salutiamo tutti come fossimo amici di liceo all’ultimo giorno di scuola dopo anni trascorsi fianco a fianco, anche se dopotutto insieme abbiamo trascorso solo qualche giornata, una avventura in kayak, una sbronza o una folle partita a bowling sulla sabbia con le noci di cocco al posto delle bocce. Si socializza più in un contesto del genere in tre giorni che in condominio di una qualsiasi città occidentale in trent’anni, statene pur certi.
Ci sono tutti, un’umanità che pare una tela di Gauguin ai tropici su una cui metà è stato appiccicato il poster del “Grande Lebowsky”. Ognuno prosegue per la sua strada per chissà dove, l’unico a rimanere, oltre alla bellissima “river people” locale, è “Geremia il matto”, un lungagnone francese appassionato di Guccini e De Andre che lavorava come portaborse al parlamento europeo a diecimila euro al mese per il papà della fidanzata, senatore della Lega! Tuttavia la notizia di una dolce attesa di una bellissima indigena sulle rive del Mekong pare sia piaciuta all’Onorevole meno persino dei gusti musicali “da comunista” del papabile genero, la cui carriera di “assistente parlamentare” s’interuppe bruscamente quel giorno per evolvere in quella di gestore di un capanno-bar su una delle 4000 isole del Mekong .
Ma l’amarcord lascia presto campo ad un triller , esce “l’addio ai monti” di Renzo Tramaglino e Lucia Mondella ed entra una prima visione di Spielberg, con un’ennesima disavventura ed un’ennesimo scampato pericolo simile ad altri ma questa volta esponenzialmente più rischioso. La similitudine è data dal ricorrere di tragitti in fiume in cui finisco trascinato dalla corrente contro rami da schivare: era successo sul battello a motore in Cambogia da Battambang a Siem Reap, con un margine di rischio tutto sommato accettabile. Ero poi finito di nuovo nei rami assassini ieri mentre ero in kayak, capottandomi nel fiume che mi trascinava giù per un buon mezzo km, e diciamo che poteva andarmi molto peggio, perché la corrente era debole in quel punto ma il Mekong un bestione che si agita come un drago mitologico, sputando qua e là mulinelli e rapide infernali. Ora davvero rischiamo grosso: la stretta e lunga lancia in legno che ci deve condurre dall’isola alla terraferma, stipata di umani e valigie oltre ogni minimo margine di sicurezza, nel bel mezzo del Mekong si inceppa. Il motore, non ne vuole più di partire, il tizio prova diverse volte a tirare la cinghia di accensione ma il catorcio raglia come un asino che inchioda le zampe a terra senza volersi muovere. Anzi no, a muovere ci muoviamo eccome se ci muoviamo ma non verso dove vogliamo andare noi: verso dove lo decide il Mekong. Sulle prime la scena suscita ironie tra noi rilassati a bordo, tranne che in un milanese imbruttito, che mantiene un atteggiamento rigido stile ragioner Zampelli dei “Ragazzi della terza C” e pone questioni come se manco stesse alla fiera del Salone nautico di Brembacazzo sul naviglio piuttosto che su una piroga in bambù nella giungla del Laos: “ue cazzofigaaaaa, ma te l’hai fatta la revisione al motore o no?” La domanda sarebbe teoricamente indirizzata nientedimeno che al marinaio indigeno della piroga, che ovviamente non gli risponde nemmeno. Ad ogni modo nel giro di qualche minuto realizziamo tutti lo stato delle cose, che proprio buono non è: siamo alla deriva in un corrente fortissima e qualche decina di metri più a valle sta un isolotto ricoperto di alberi e rami, verso cui ci stiamo andando a schiantare. Una donna sale sulla prua e agita un enorme palo di bambù a mo di timone per schivare l’ostacolo ma è tardi:  l’impatto ormai è inevitabile: memore della esperienza del giorno prima (quando per schivare i rami ci siamo sbilanciati tutti verso un lato facendo rovesciare il kayak) , prendo a urlare a tutti di stare a terra e non buttarsi in un lato. Non saprei dire se mi abbiamo ascoltato o meno, fatto sta che con molta buona sorte evitamo un ribaltamento della barca che davvero avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Una tempesta di rami e rovi ci passa sopra le teste come il fuoco di una mitragliatrice, ci graffia braccia, schiena, gambe. Siamo fortunati da non sbattere contro masso o ostacolo rigido che a quella velocità sarebbe stato bruttarello, poi un ragazzino locale davvero con un gesto allaTarzan prende con le gambe in orizzontale a fare al volo leva contro un tronco allontanando di quel mezzo metro la barca per permetterci di passare oltre. Siamo passati, qualche graffio per tutti ma nulla più. Ora peró qualcuno dovrà venire a prenderci, perché siamo ancora alla deriva: con una difficile manovra una seconda piroga ci aggancia e ci fa accostare in un punto dell’isolotto risparmiato dalla corrente. Trasbordiamo e siamo in salvo. Questa davvero me la ricordo finché campo
l’impatto ormai è inevitabile: memore della esperienza del giorno prima (quando per schivare i rami ci siamo sbilanciati tutti verso un lato facendo rovesciare il kayak) , prendo a urlare a tutti di stare a terra e non buttarsi in un lato. Non saprei dire se mi abbiamo ascoltato o meno, fatto sta che con molta buona sorte evitamo un ribaltamento della barca che davvero avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Una tempesta di rami e rovi ci passa sopra le teste come il fuoco di una mitragliatrice, ci graffia braccia, schiena, gambe. Siamo fortunati da non sbattere contro masso o ostacolo rigido che a quella velocità sarebbe stato bruttarello, poi un ragazzino locale davvero con un gesto allaTarzan prende con le gambe in orizzontale a fare al volo leva contro un tronco allontanando di quel mezzo metro la barca per permetterci di passare oltre. Siamo passati, qualche graffio per tutti ma nulla più. Ora peró qualcuno dovrà venire a prenderci, perché siamo ancora alla deriva: con una difficile manovra una seconda piroga ci aggancia e ci fa accostare in un punto dell’isolotto risparmiato dalla corrente. Trasbordiamo e siamo in salvo. Questa davvero me la ricordo finché campo
Grazie Mekong!
Giunto in terraferma, mi dirigo a nord verso una cittadona chiamata Pakse, vicino tra l’altro ad un altro tesoro di architettura khmer, il magnifico tempio di Wat Phu, immerso davvero nella giungla impenetrabile di una montagna a cazzo, nel senso letterale che si chiama in lingua locale “il Monte Pene”.  Vorrei arrisicarmi in qualche modo ma è piuttosto difficile la visita nella stagione delle piogge per vie dei torrenti rigonfi d’acqua. Mi limito così a prendere un banale aereo per volare a nord del Laos verso una città che si annuncia bellissima chiamata Luang Prabang. In verità avrei un mio codice interno per cui dovrei giungere alla meta finale via terra: con l’aereo so’boni tutti e mi ammazza il gusto. Ma un piccolo volo interno al Laos con la compagnia di bandiera locale possiede quel margine di brivido e avventura utile a indorare la pillola.
Vorrei arrisicarmi in qualche modo ma è piuttosto difficile la visita nella stagione delle piogge per vie dei torrenti rigonfi d’acqua. Mi limito così a prendere un banale aereo per volare a nord del Laos verso una città che si annuncia bellissima chiamata Luang Prabang. In verità avrei un mio codice interno per cui dovrei giungere alla meta finale via terra: con l’aereo so’boni tutti e mi ammazza il gusto. Ma un piccolo volo interno al Laos con la compagnia di bandiera locale possiede quel margine di brivido e avventura utile a indorare la pillola.
Ed eccomi nella splendida Luang Prabang di cui andrò domani alla scoperta. La città sorge adagiata alla confluenza di due fiumi, il Nam Kam e ovviamente ….
il Mekong, che qui scorre più placido e dolce, almeno fin che vuole: oggi ho capito che è molto più di un fiume, è qualcosa di simile al Nilo per gli antichi Egizi, un Dio che da la vita e può toglierla. Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi vicenda umana abbia luogo sulle rive del Mekong, la decide il Mekong.


 in realtà poco più che un gettito di sabbia e fango compatto che il Mekong lascia per strada nella sua corsa verso sud, uno sputo solidificato che il Grande Fiume potrebbe ringhiottire con la facilità con cui un Polifemo si nutre dei compagni di Ulisse prima dell’accecamento. Il riferimento all’Odissea non è speso male, perché il contesto naturale è davvero “post-omerico”, mi si consenta il brevetto di questo affascinante concetto che mi piace proprio assai. Questa è la terra mitica dei mangiatori di loto, i fiori che danno l’oblio, sempre che di terra possa parlarsi atteso che si ha la sensazione di essere su qualche zattera semovente gettata nel Mekong.
in realtà poco più che un gettito di sabbia e fango compatto che il Mekong lascia per strada nella sua corsa verso sud, uno sputo solidificato che il Grande Fiume potrebbe ringhiottire con la facilità con cui un Polifemo si nutre dei compagni di Ulisse prima dell’accecamento. Il riferimento all’Odissea non è speso male, perché il contesto naturale è davvero “post-omerico”, mi si consenta il brevetto di questo affascinante concetto che mi piace proprio assai. Questa è la terra mitica dei mangiatori di loto, i fiori che danno l’oblio, sempre che di terra possa parlarsi atteso che si ha la sensazione di essere su qualche zattera semovente gettata nel Mekong.  Qui il fiume arriva a misurare da una sponda all’altra la bellezza di 14 km (per capirci più del braccio di mare che separa Capri da Sorrento) e, prima di travolgere la Cambogia, si contorce un po’ nervosamente nel suo letto qui, disseminandolo di macchie alberate. La denominazione “4000 isole sul Mekong” che pare sulle prime un iperbole nel neonato stile “post-omerico” è invece tutto sommato realistico, a condizione di poter chiamare isole anche le più piccole striscie di sabbia emergenti dal gorgo. Don Det, insieme con Don Khong è una delle relativamente più estese,
Qui il fiume arriva a misurare da una sponda all’altra la bellezza di 14 km (per capirci più del braccio di mare che separa Capri da Sorrento) e, prima di travolgere la Cambogia, si contorce un po’ nervosamente nel suo letto qui, disseminandolo di macchie alberate. La denominazione “4000 isole sul Mekong” che pare sulle prime un iperbole nel neonato stile “post-omerico” è invece tutto sommato realistico, a condizione di poter chiamare isole anche le più piccole striscie di sabbia emergenti dal gorgo. Don Det, insieme con Don Khong è una delle relativamente più estese,  dove è possibile alla river people una vita di pesca e coltivazione del riso negli anfratti di terra non troppo sommersi
dove è possibile alla river people una vita di pesca e coltivazione del riso negli anfratti di terra non troppo sommersi Due delle cose che meno amo al mondo sono qui completamente assenti, parlo del cemento e dell’asfalto, mentre due sono le sole strade che esistono a Don Det e non sono certo intitolate ai Mazzini e Cavour locali, giacche si chiamano figuratevi Sunrise strip per quella che corre lungo la costa est e che assiste dunque all’alba, e poi sta Sunset strip sulla costa opposta, quella che vede il tramonto. Tra l’Alba e il Tramonto o viceversa (sono concetti arrotolati uno nell’altro da ste parti), vive entro palafitte di legno una comunità a suo modo variegata e unica, dove agli indigeni, fermi davvero ad un mondo di cento anni fa, si è andata ad unire e a ben amalgamare una umanità di occidentali in fuga dal proprio mondo, dai ritmi che non lasciano scampo alle emozioni e dalle mille responsabilità
Due delle cose che meno amo al mondo sono qui completamente assenti, parlo del cemento e dell’asfalto, mentre due sono le sole strade che esistono a Don Det e non sono certo intitolate ai Mazzini e Cavour locali, giacche si chiamano figuratevi Sunrise strip per quella che corre lungo la costa est e che assiste dunque all’alba, e poi sta Sunset strip sulla costa opposta, quella che vede il tramonto. Tra l’Alba e il Tramonto o viceversa (sono concetti arrotolati uno nell’altro da ste parti), vive entro palafitte di legno una comunità a suo modo variegata e unica, dove agli indigeni, fermi davvero ad un mondo di cento anni fa, si è andata ad unire e a ben amalgamare una umanità di occidentali in fuga dal proprio mondo, dai ritmi che non lasciano scampo alle emozioni e dalle mille responsabilità  per ricostruirne una su basi più gracili come questi sedimenti sabbiosi ma più felice e fissata in belle massime di vita scolpite in pannelli in legno che pendono da tutti i soffitti delle casupole, in una singolare gara a chi espone la sentenza più originale
per ricostruirne una su basi più gracili come questi sedimenti sabbiosi ma più felice e fissata in belle massime di vita scolpite in pannelli in legno che pendono da tutti i soffitti delle casupole, in una singolare gara a chi espone la sentenza più originale 

 L’isola non vanta grosse tradizioni culinarie, eccezion fatta per la pasticceria di alto livello: sulle tavole di ogni locale di Don Det potrete assaggiare, se proprio ne avete voglia, i cd “happy cakes”, specialità della casa che compendia un impasto di pan di Spagna, mango, cioccolato e…..marjuana. La versione 2.0 dei mitologici fiori di loto insomma . A giudicare dagli effetti che noto sui suoi degustatori mi pare di capire sia buono. Ma come occupa poi la scanzonata gente di Don Det il suo tempo nell’arco della giornata? Partecipando per esempio alle magnifiche escursioni in kayak sulle rapide del Mekong organizzati da Mr. Mu (che non sta per mister Muscolo dal momento che ha una panza che io a confronto sono un pallanuotista).
L’isola non vanta grosse tradizioni culinarie, eccezion fatta per la pasticceria di alto livello: sulle tavole di ogni locale di Don Det potrete assaggiare, se proprio ne avete voglia, i cd “happy cakes”, specialità della casa che compendia un impasto di pan di Spagna, mango, cioccolato e…..marjuana. La versione 2.0 dei mitologici fiori di loto insomma . A giudicare dagli effetti che noto sui suoi degustatori mi pare di capire sia buono. Ma come occupa poi la scanzonata gente di Don Det il suo tempo nell’arco della giornata? Partecipando per esempio alle magnifiche escursioni in kayak sulle rapide del Mekong organizzati da Mr. Mu (che non sta per mister Muscolo dal momento che ha una panza che io a confronto sono un pallanuotista).  Il fiume qui si contorce in una serie di rapide e cascate dalla forza e gittata impressionante, inoltre più a valle, proprio nello spazio d’acqua dinanzi alla Cambogia vive uno sparuto gruppo di delfini di acqua dolce, il cui avvistamento pare garantito con un po’ di pazienza e occhio lungo. Io faccio squadra in kayak con il mitico Jason, un lungagnone australiano che pare uscito dal grande Lebowsky, le cui enormi potenzialità appaiono subito chiare nel contemplarlo fare colazione a whisky & cigarettes….
Il fiume qui si contorce in una serie di rapide e cascate dalla forza e gittata impressionante, inoltre più a valle, proprio nello spazio d’acqua dinanzi alla Cambogia vive uno sparuto gruppo di delfini di acqua dolce, il cui avvistamento pare garantito con un po’ di pazienza e occhio lungo. Io faccio squadra in kayak con il mitico Jason, un lungagnone australiano che pare uscito dal grande Lebowsky, le cui enormi potenzialità appaiono subito chiare nel contemplarlo fare colazione a whisky & cigarettes….
 nella sua forma un po’ tozza e una testona deforme che francamente mi ha ricordato la forma di un pisello. Per capirci vi mostro una foto di repertorio non certo scattata da me
nella sua forma un po’ tozza e una testona deforme che francamente mi ha ricordato la forma di un pisello. Per capirci vi mostro una foto di repertorio non certo scattata da me  vi e poi tempo per una faticosa risalita in kayak in territorio laotiano fino ad un’altra roboante cascata, la cd Khone Papheng in cui il Mekong davvero si mostra con la potenza di una divinità
vi e poi tempo per una faticosa risalita in kayak in territorio laotiano fino ad un’altra roboante cascata, la cd Khone Papheng in cui il Mekong davvero si mostra con la potenza di una divinità  Secondo me gliela tagliano ma sento dire che si tratti di una razza locale: il fatto è che lo sento dire ai consumatori dei pan di Spagna bagnati alla maria che certo non paiono dei campioni di attendibilità.
Secondo me gliela tagliano ma sento dire che si tratti di una razza locale: il fatto è che lo sento dire ai consumatori dei pan di Spagna bagnati alla maria che certo non paiono dei campioni di attendibilità.
 Gli hippie o freak volevano cambiare il mondo per provare a riscriverlo con poche e semplici ingenue regole di vita. Ad un certo punto della storia erano diventati tanti e gonfiarono le università e le piazze ma non era ovviamente che una stagione fugace. Furono presto sconfitti e dalle città arretrarono alle campagne, poi a posti sempre più remoti dove mettere su una vita rilassata e basata su poche convenzioni. Le 4000 isole sul Mekong restano la loro inespugnabile Stalingrado, con la loro ubicazione così impervia in un buco del culo dell’Atlante geografico e il Mekong gigante buono a proteggerli con le sue rapide e cascate dal Progresso, altro gigante a volte buono a volte no. È un luogo magico e crepuscolare che scomparirà da un giorno all’altro come queste isole che prima o poi il Grande Fiume inghiottirà . Sta da capire insomma quale dei due Giganti farà prima in una mitologica contesa. Per ora le 4000 isole vivono e sono la realizzazione di una vera e propria utopia, nel senso quasi scientifico del termine (sarebbe più corretto parlare di “ectopia” ma vabbè): queste isole sono la declinazione freakkettona del regno di Utopia
Gli hippie o freak volevano cambiare il mondo per provare a riscriverlo con poche e semplici ingenue regole di vita. Ad un certo punto della storia erano diventati tanti e gonfiarono le università e le piazze ma non era ovviamente che una stagione fugace. Furono presto sconfitti e dalle città arretrarono alle campagne, poi a posti sempre più remoti dove mettere su una vita rilassata e basata su poche convenzioni. Le 4000 isole sul Mekong restano la loro inespugnabile Stalingrado, con la loro ubicazione così impervia in un buco del culo dell’Atlante geografico e il Mekong gigante buono a proteggerli con le sue rapide e cascate dal Progresso, altro gigante a volte buono a volte no. È un luogo magico e crepuscolare che scomparirà da un giorno all’altro come queste isole che prima o poi il Grande Fiume inghiottirà . Sta da capire insomma quale dei due Giganti farà prima in una mitologica contesa. Per ora le 4000 isole vivono e sono la realizzazione di una vera e propria utopia, nel senso quasi scientifico del termine (sarebbe più corretto parlare di “ectopia” ma vabbè): queste isole sono la declinazione freakkettona del regno di Utopia 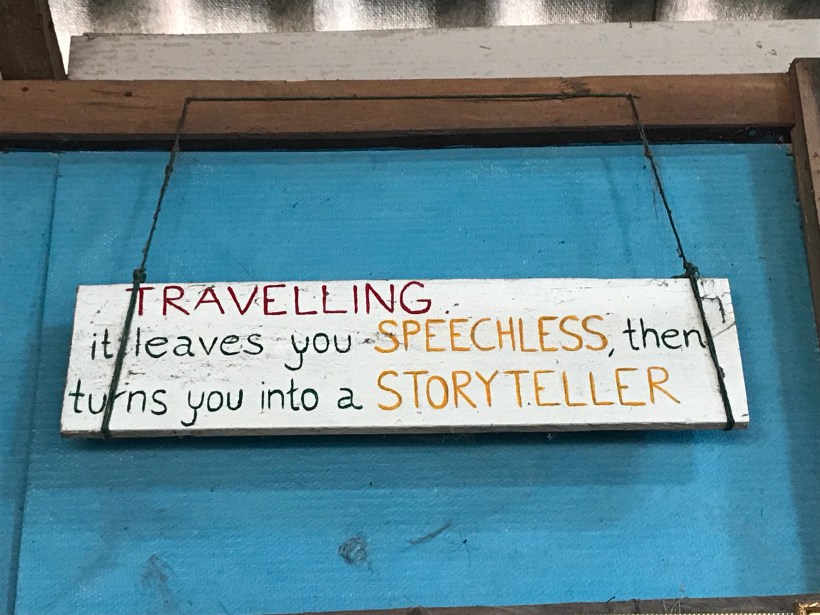




 Tredici ore di odissea per essere qui ma capiamo subito che ne è valsa la pena: questa è la mitologica Terra dei Mangiatori di loto, un posto fuori dal mondo in ogni senso, di cui capisco subito che mi innamorerò perdutamente ma di questo parleremo domani.
Tredici ore di odissea per essere qui ma capiamo subito che ne è valsa la pena: questa è la mitologica Terra dei Mangiatori di loto, un posto fuori dal mondo in ogni senso, di cui capisco subito che mi innamorerò perdutamente ma di questo parleremo domani.  A proposito di fiori di loto, il pensiero va ovviamente al mio grande amico Jerry, il Loto per antonomasia: mi pare subito di capire che questo è il posto suo, ce lo vedrei proprio bene qua, anzi mi pare che ci manca sul’iss…
A proposito di fiori di loto, il pensiero va ovviamente al mio grande amico Jerry, il Loto per antonomasia: mi pare subito di capire che questo è il posto suo, ce lo vedrei proprio bene qua, anzi mi pare che ci manca sul’iss…

 Per non parlare di alberghi e ristoranti: il delizioso Amok è diventato una sorta di catena di ristorazione dove il pesce del lago Tonle Sap avvolto nel tamarindo ha la stessa freschezza di un cheeseburger da Macdonald, ovunque poi albergoni e resort per ogni tasca ed esigenza. Quasi inevitabile che finisca così, vista la massa di gente interessata a visitare una meraviglia come l’Angkor What e sta comunque da aggiungere che Siem Reap ha saputo reinventarsi come capitale turistica della intera area, pur sacrificando la sua vecchia aurea da posto hippie sull’altare del marketing turistico e degli enormi profitti. Detto questo, forse possiamo passare oltre un posto che a molto di voi dirà poco o nulla come Siem Reap e guardare al motivo prevalente di una visita in questa parte di mondo ovvero l’Angkor Wat.
Per non parlare di alberghi e ristoranti: il delizioso Amok è diventato una sorta di catena di ristorazione dove il pesce del lago Tonle Sap avvolto nel tamarindo ha la stessa freschezza di un cheeseburger da Macdonald, ovunque poi albergoni e resort per ogni tasca ed esigenza. Quasi inevitabile che finisca così, vista la massa di gente interessata a visitare una meraviglia come l’Angkor What e sta comunque da aggiungere che Siem Reap ha saputo reinventarsi come capitale turistica della intera area, pur sacrificando la sua vecchia aurea da posto hippie sull’altare del marketing turistico e degli enormi profitti. Detto questo, forse possiamo passare oltre un posto che a molto di voi dirà poco o nulla come Siem Reap e guardare al motivo prevalente di una visita in questa parte di mondo ovvero l’Angkor Wat.  Che dire mai di un posto del genere? Non saprei neanche da come cominciare. Diciamo che non vi è foto, video o altro strumento di riproduzione tecnologica che ne può rendere la magnificenza o la bellezza. Si tratta del sito archeologico più vasto al mondo, esteso per decine di km quadrati, una delle edificazioni più ispirate che la mente umana abbia mai concepito.
Che dire mai di un posto del genere? Non saprei neanche da come cominciare. Diciamo che non vi è foto, video o altro strumento di riproduzione tecnologica che ne può rendere la magnificenza o la bellezza. Si tratta del sito archeologico più vasto al mondo, esteso per decine di km quadrati, una delle edificazioni più ispirate che la mente umana abbia mai concepito. 

 La denominazione “Angkor Wat”, con cui è universalmente conosciuta è tra l’altro riferibile in verità solo ad uno, il più maestoso degli oltre 4.500 (si, proprio così quattromilacinquecento) templi qui edificati, alcuni dei quali ammantati in una fitta giungla che ne finisce per amplificare la bellezza
La denominazione “Angkor Wat”, con cui è universalmente conosciuta è tra l’altro riferibile in verità solo ad uno, il più maestoso degli oltre 4.500 (si, proprio così quattromilacinquecento) templi qui edificati, alcuni dei quali ammantati in una fitta giungla che ne finisce per amplificare la bellezza 
 Tanta bellezza finisce per disorientare e almeno a me è capitato di cercare una via di interpretazione nella visita più lateral, che partisse dai dettagli per salire alle stelle, come ad esempio l’osservazione dei centinaia di migliaia di bassorilievi (ancora una volta il numero non è foriero di alcuna esagerazione) che ricostruiscono le vicende della storia khmer e dell’ascesa dei loro re, su tutti Javavarman II, nome che gli appassionati di cacce al tesoro palillesche faranno bene a ricordare….
Tanta bellezza finisce per disorientare e almeno a me è capitato di cercare una via di interpretazione nella visita più lateral, che partisse dai dettagli per salire alle stelle, come ad esempio l’osservazione dei centinaia di migliaia di bassorilievi (ancora una volta il numero non è foriero di alcuna esagerazione) che ricostruiscono le vicende della storia khmer e dell’ascesa dei loro re, su tutti Javavarman II, nome che gli appassionati di cacce al tesoro palillesche faranno bene a ricordare…. Personalmente non riesco a credere, come altre religioni fanno, che noi umani siamo destinati a reincarnarci in altre essenze e a vivere altre vite; per quanto mi riguarda ci è stata data solo una vita: non fatela trascorrere senza aver mai visto l’Angkor Wat
Personalmente non riesco a credere, come altre religioni fanno, che noi umani siamo destinati a reincarnarci in altre essenze e a vivere altre vite; per quanto mi riguarda ci è stata data solo una vita: non fatela trascorrere senza aver mai visto l’Angkor Wat


 una città galleggiante che porta in qualche modo le stigmate del progresso nei suoi aspetti deteriori, ad esempio l’inquinamento presente in quintali di plastica galleggiante e un’acqua putrida in cui incredibilmente i locali si lavano e fanno il bagno. La successiva fase di navigazione si apre ad uno scenario diverso, più tipicamente fluviale su ampi canali, siamo ormai sul lago Tonle Sap, culla della civiltà khmer, pietra angolare liquida di questa cultura che da queste acque seppe ricavare prosperità e fulgore. Proprio sulla parete d’entrata dell’Angkor Wat è scolpito un lunghissimo bassorilievo che narra di una battaglia cruciale tra i khmer e i loro eterni rivali Cham (gli attuali vietnamiti) con esito favorevole ai primi
una città galleggiante che porta in qualche modo le stigmate del progresso nei suoi aspetti deteriori, ad esempio l’inquinamento presente in quintali di plastica galleggiante e un’acqua putrida in cui incredibilmente i locali si lavano e fanno il bagno. La successiva fase di navigazione si apre ad uno scenario diverso, più tipicamente fluviale su ampi canali, siamo ormai sul lago Tonle Sap, culla della civiltà khmer, pietra angolare liquida di questa cultura che da queste acque seppe ricavare prosperità e fulgore. Proprio sulla parete d’entrata dell’Angkor Wat è scolpito un lunghissimo bassorilievo che narra di una battaglia cruciale tra i khmer e i loro eterni rivali Cham (gli attuali vietnamiti) con esito favorevole ai primi  ma di questo parleremo semmai domani. Schivato che è il rischio dei rami fendenti, sul battello possiamo rilassarci e salire sul tetto panoramico
ma di questo parleremo semmai domani. Schivato che è il rischio dei rami fendenti, sul battello possiamo rilassarci e salire sul tetto panoramico  ci resta ancora tempo per l’attraversamento della palude in cui ha sede la eccezionale riserva avio-faunistica del Prek Toal
ci resta ancora tempo per l’attraversamento della palude in cui ha sede la eccezionale riserva avio-faunistica del Prek Toal un paesaggio forse un po’ spettrale ma davvero un paradiso per gli appassionati di birdwatching che qui possono avvistare specie ormai quasi estinte come il mitologico Ibis gigante o l’avvoltoio testarossa. Giungiamo a destinazione dopo circa 9 ore, in un ennesimo villaggio galleggiante alle porte di Siem Reap, la capitale turistica della Cambogia per la sua vicinanza ai templi dell’Angkor Wat. Un bellissimo viaggio in battello, e domani si visita una delle sette meraviglie del mondo, l’Angkor Wat. Non male, direi
un paesaggio forse un po’ spettrale ma davvero un paradiso per gli appassionati di birdwatching che qui possono avvistare specie ormai quasi estinte come il mitologico Ibis gigante o l’avvoltoio testarossa. Giungiamo a destinazione dopo circa 9 ore, in un ennesimo villaggio galleggiante alle porte di Siem Reap, la capitale turistica della Cambogia per la sua vicinanza ai templi dell’Angkor Wat. Un bellissimo viaggio in battello, e domani si visita una delle sette meraviglie del mondo, l’Angkor Wat. Non male, direi


 , dove avviene un incontro sorprendente: mentre mi intrattengo con delle trote che mi ricordavano le caprette di Villa jovis nel loro aver maturato una abitudine alla presenza umana e nell’attendere da essa offerte di cibo, appare proprio sotto lo scoglio sul quale sono appollaiato una tartaruga di fiume di dimensioni considerevoli
, dove avviene un incontro sorprendente: mentre mi intrattengo con delle trote che mi ricordavano le caprette di Villa jovis nel loro aver maturato una abitudine alla presenza umana e nell’attendere da essa offerte di cibo, appare proprio sotto lo scoglio sul quale sono appollaiato una tartaruga di fiume di dimensioni considerevoli
 e nel cui “sagrato” è possibile anche nuotare, se avete lo stomaco di attraversare prima la corrente attaccati ad una malferma corda nei pressi di una rapida e inerpicarvi poi su una roccia scivolosissima.
e nel cui “sagrato” è possibile anche nuotare, se avete lo stomaco di attraversare prima la corrente attaccati ad una malferma corda nei pressi di una rapida e inerpicarvi poi su una roccia scivolosissima.  Ovviamente non riesco a resistere proprio alla tentazione…..
Ovviamente non riesco a resistere proprio alla tentazione….. La corrente e certi “colli di mare” belli grossi ci si mettono di impegno a guastarmi la festa ma alla fine approdo, sentendomi un po’ come il mitico Gennarino Carunchio in ” Travolti da un insolito destino…etc” alla ricerca della sua Mariangela Melato “bottana industriale “.
La corrente e certi “colli di mare” belli grossi ci si mettono di impegno a guastarmi la festa ma alla fine approdo, sentendomi un po’ come il mitico Gennarino Carunchio in ” Travolti da un insolito destino…etc” alla ricerca della sua Mariangela Melato “bottana industriale “.  Scherzi a parte, il paesaggio è davvero paradisiaco
Scherzi a parte, il paesaggio è davvero paradisiaco 



 In pratica la presenza dell’uomo a Koh Chang è avviluppata tutta intorno ad una bizzarra strada che corre lungo tutti il perimetro dell’isola, tra balze e dossi più simili a quelli di montagne russe al luna park che a quelli di una via di collegamento. L’intero territorio dell’isola è parco naturale, la cui attrattiva principale è offerta dalle tante cascate da cui sgorga la tanta acqua che cade dal cielo; ad ogni modo la mano umana ha fatto sentire la sua presenza anche qui, con tanti resort di recente edificazione che spesso monopolizzano in maniera brutale le tante spiagge dell’isola. Il turismo di massa in ogni caso è a Koh Chang scongiurato per via delle già citate frequentissime piogge di , che la rendono un posto ostile ai fanatici della tintarella.
In pratica la presenza dell’uomo a Koh Chang è avviluppata tutta intorno ad una bizzarra strada che corre lungo tutti il perimetro dell’isola, tra balze e dossi più simili a quelli di montagne russe al luna park che a quelli di una via di collegamento. L’intero territorio dell’isola è parco naturale, la cui attrattiva principale è offerta dalle tante cascate da cui sgorga la tanta acqua che cade dal cielo; ad ogni modo la mano umana ha fatto sentire la sua presenza anche qui, con tanti resort di recente edificazione che spesso monopolizzano in maniera brutale le tante spiagge dell’isola. Il turismo di massa in ogni caso è a Koh Chang scongiurato per via delle già citate frequentissime piogge di , che la rendono un posto ostile ai fanatici della tintarella. La scelta si rivela azzeccata : è il posto più suggestivo dell’isola ma, rimanga tra noi, all’arrivo lascio perdere gli hippie e vengo rapito da un resort ubicato dietro una collina, ove la strada precipita su una spiaggia incantata di fronte a diversi isolotti.
La scelta si rivela azzeccata : è il posto più suggestivo dell’isola ma, rimanga tra noi, all’arrivo lascio perdere gli hippie e vengo rapito da un resort ubicato dietro una collina, ove la strada precipita su una spiaggia incantata di fronte a diversi isolotti.
 a ben vedere la stessa linea di marea funge da linea di trincea tra due eserciti che si combattono, quello dei granchi è quello delle formiche. Ma alzando gli occhi lo spettacolo è tutto davanti a te con il mare verdognolo che sembra baciarti, i cormorani intenti in una perigliosa pesca, gli isolotti sullo sfondo e poi palme, mangrovie, camelie in fiore alle spalle. E allora non resta che intonare ancora Battiato (vediamo chi becca le due citazioni): “🎶mare mare mare, voglio annegareee 🎶 , portami lontano a naufragareee 🎶 🎶 ”
a ben vedere la stessa linea di marea funge da linea di trincea tra due eserciti che si combattono, quello dei granchi è quello delle formiche. Ma alzando gli occhi lo spettacolo è tutto davanti a te con il mare verdognolo che sembra baciarti, i cormorani intenti in una perigliosa pesca, gli isolotti sullo sfondo e poi palme, mangrovie, camelie in fiore alle spalle. E allora non resta che intonare ancora Battiato (vediamo chi becca le due citazioni): “🎶mare mare mare, voglio annegareee 🎶 , portami lontano a naufragareee 🎶 🎶 ” 
 La macchina mi lascia in una località chiamata Ban Phe, un molo di pescatori che solcano i mari su bei pescherecci in legno assai datati
La macchina mi lascia in una località chiamata Ban Phe, un molo di pescatori che solcano i mari su bei pescherecci in legno assai datati  alcuni di essi sono adibiti al trasporto passeggeri sull’isola frontaliera ma subiscono la sfacciata concorrenza di spietati bucanieri che si servono per lo stesso servizio di più avvenenti motoscafi capaci di sfrecciare a velocità doppia se non tripla rispetto ai poveri pescherecci e di attraccare, con assai poco rispetto per l’ambiente e i bagnanti, su qualsiasi spiaggia a scelta dell’utente. Naturalmente sarei propenso al disadorno peschereccio ma la gamba a mezzo servizio mi constringe ad abboccare al primo motoscafista che mi si fionda incontro e mi carica su sti cessi ad alta velocità e rumorosissimo motore. Lo sbarco nondimeno avviene in puro Briatore style, col motore acceso in mezzo a bambini che nuotano su una spiaggia immacolata oltre la quale sorge l’abitato principale che, come sempre accade, trovo molto mutato dalla prima visita qui una quindicina di anni orsono.
alcuni di essi sono adibiti al trasporto passeggeri sull’isola frontaliera ma subiscono la sfacciata concorrenza di spietati bucanieri che si servono per lo stesso servizio di più avvenenti motoscafi capaci di sfrecciare a velocità doppia se non tripla rispetto ai poveri pescherecci e di attraccare, con assai poco rispetto per l’ambiente e i bagnanti, su qualsiasi spiaggia a scelta dell’utente. Naturalmente sarei propenso al disadorno peschereccio ma la gamba a mezzo servizio mi constringe ad abboccare al primo motoscafista che mi si fionda incontro e mi carica su sti cessi ad alta velocità e rumorosissimo motore. Lo sbarco nondimeno avviene in puro Briatore style, col motore acceso in mezzo a bambini che nuotano su una spiaggia immacolata oltre la quale sorge l’abitato principale che, come sempre accade, trovo molto mutato dalla prima visita qui una quindicina di anni orsono.  Ricordavo una esigua striscia di capanne e bungalow adagiati sulla sabbia, ora sostituiti da più robusti edifici in calcestruzzo gettati sul bagnasciuga piuttosto alla rinfusa. Altra differenza che noto è la presenza delle forze dell’ordine anzi addirittura dell’esercito, mentre allora ricordo benissimo che gli hippie si crogiolavano felici nei loro infiniti cannoni di marijuana, consci che non vi era un solo poliziotto in tutta Koh Samet. Ad ogni modo il luogo pare ancora pervaso da un’atmosfera hippie, che è comunque qualcosa che si manifesta solo a partire dalle ore pomeridiane andando verso la sera: nel senso che la mattina l’atmosfera hippie esiste solo come stordimento perché gli hippie dormono e devono ancora riprendersi dalla sera prima. Ne becco infatti una che lavorerebbe in un bar teoricamente aperto e che pare quella che esce dalla videocassetta del film “the ring” per quanto sta intronata: ci mette tipo 5 minuti a capire che voglio un’aranciata, non vi dico quanto impiega a dirmi la password del wi-fi, che poi non è chissà quale parola complicata ma una semplice sequenza di numeri dall’uno al nove. Insomma 1234456789, questo deve dire….ahe, me ne vado per un’idea quando arriva a pronunciare il tre e le risparmio il supplizio di dire gli altri sei, operazione che avrebbe rischiesto il tempo in cui Ray Manzarek si produce in un assolo di pianoforte mentre Jim Morrison balla sulle note di “The end” dei Doors ovviamente.
Ricordavo una esigua striscia di capanne e bungalow adagiati sulla sabbia, ora sostituiti da più robusti edifici in calcestruzzo gettati sul bagnasciuga piuttosto alla rinfusa. Altra differenza che noto è la presenza delle forze dell’ordine anzi addirittura dell’esercito, mentre allora ricordo benissimo che gli hippie si crogiolavano felici nei loro infiniti cannoni di marijuana, consci che non vi era un solo poliziotto in tutta Koh Samet. Ad ogni modo il luogo pare ancora pervaso da un’atmosfera hippie, che è comunque qualcosa che si manifesta solo a partire dalle ore pomeridiane andando verso la sera: nel senso che la mattina l’atmosfera hippie esiste solo come stordimento perché gli hippie dormono e devono ancora riprendersi dalla sera prima. Ne becco infatti una che lavorerebbe in un bar teoricamente aperto e che pare quella che esce dalla videocassetta del film “the ring” per quanto sta intronata: ci mette tipo 5 minuti a capire che voglio un’aranciata, non vi dico quanto impiega a dirmi la password del wi-fi, che poi non è chissà quale parola complicata ma una semplice sequenza di numeri dall’uno al nove. Insomma 1234456789, questo deve dire….ahe, me ne vado per un’idea quando arriva a pronunciare il tre e le risparmio il supplizio di dire gli altri sei, operazione che avrebbe rischiesto il tempo in cui Ray Manzarek si produce in un assolo di pianoforte mentre Jim Morrison balla sulle note di “The end” dei Doors ovviamente. 
 bello stare qui su questa mezza luna di sabbia su cui si affacciano cormorani e tanti uccelli,
bello stare qui su questa mezza luna di sabbia su cui si affacciano cormorani e tanti uccelli,  mentre la sera sulla terrazza del ristorante un numero impressionate di rame da luogo ad un allucinato concerto proprio sotto i miei piedi
mentre la sera sulla terrazza del ristorante un numero impressionate di rame da luogo ad un allucinato concerto proprio sotto i miei piedi  Ad ogni modo un bel soggiorno qui, con un alba che si rivela improvvisamente sopra la spiaggia tra noci di cocco e mangrovie e mi fa finalmente capire di essere ai tropici ah
Ad ogni modo un bel soggiorno qui, con un alba che si rivela improvvisamente sopra la spiaggia tra noci di cocco e mangrovie e mi fa finalmente capire di essere ai tropici ah

 un centinaio di km a sud di Bangkok lungo la costa orientale del paese, quella che degrada verso le pianure alluvionali del Mekong e verso la Cambogia e il Vietnam. Parlare di pianure alluvionali o quel che sia di qualsivoglia elemento naturistico, montagne, fiumi etc, è a Pattaya del tutto ultroneo e superfluo, giacche si distinguono ivi due unici elementi: cemento e asfalto, amalgamati da un’atmosfera talmente pregna di smog che vi sembrerà dopo una mezz’oretta di aver limonato con la marmitta di un camion. Figurarsi che persino la Lonely Planet , che in un ecumenismo sospinto da motivazioni commerciali riesce a trovare di qualche interesse urbanistico persino luoghi come il Centro direzionale di Napoli o la casa di un topo, a proposito di Pattaya esordisce così: “se siete diretti a Pattaya con l’intenzione di risiedere in un tranquillo resort adagiato su una placida spiaggia tropicale, fate immediatamente inversione a U e allontanatevi il più possibile”. Il motivo che spinge una fetta di umanità a scegliere Pattaya come destinazione per le proprie vacanze è presto detto: il mestiere più antico del mondo, che qui si produce in un’offerta ampia e diversificata più del menu a tendina delle categories di un sito porno. A fianco, è possibile qui esercitarsi in una vasta gamma di activities pescate tra le più sgraziate e tamarre che gusto umano possa conoscere : si può giocare alla guerra finta con armi automatiche e mitragliatori giocattolo, visitare uno zoo dove stanno stipate in mangiatoie rarissime tigri siberiane in via d’estinzione, assistere a match di mixed martial arts (dove è mai l’arte?) tra strani ircocervi in perizoma, offrire prebende di cibo vivo a squali in gabbia e molte altre. A dire il vero sembra sia in atto una riconversione turistica del luogo per tramutarlo da market della prostituzione a polo di attrattiva di grossi centri commerciali….wow. In sintonia con il main stream “pattayense”, mi scelgo un bell’albergone tamarro di quelli che a centinaia affollano il lungomare, tale hotel Grand Palazzo, che potrà forse vantare la pregiata consulenza architettonica di Genny Savastano per lo stile sobrio ed eseenziale nonché per questi eleganti scaloni in finto marmo che con moltissima fantasia potrebbero ricordare le prospettive vanvitelliane di qualche palazzo reale italiano
un centinaio di km a sud di Bangkok lungo la costa orientale del paese, quella che degrada verso le pianure alluvionali del Mekong e verso la Cambogia e il Vietnam. Parlare di pianure alluvionali o quel che sia di qualsivoglia elemento naturistico, montagne, fiumi etc, è a Pattaya del tutto ultroneo e superfluo, giacche si distinguono ivi due unici elementi: cemento e asfalto, amalgamati da un’atmosfera talmente pregna di smog che vi sembrerà dopo una mezz’oretta di aver limonato con la marmitta di un camion. Figurarsi che persino la Lonely Planet , che in un ecumenismo sospinto da motivazioni commerciali riesce a trovare di qualche interesse urbanistico persino luoghi come il Centro direzionale di Napoli o la casa di un topo, a proposito di Pattaya esordisce così: “se siete diretti a Pattaya con l’intenzione di risiedere in un tranquillo resort adagiato su una placida spiaggia tropicale, fate immediatamente inversione a U e allontanatevi il più possibile”. Il motivo che spinge una fetta di umanità a scegliere Pattaya come destinazione per le proprie vacanze è presto detto: il mestiere più antico del mondo, che qui si produce in un’offerta ampia e diversificata più del menu a tendina delle categories di un sito porno. A fianco, è possibile qui esercitarsi in una vasta gamma di activities pescate tra le più sgraziate e tamarre che gusto umano possa conoscere : si può giocare alla guerra finta con armi automatiche e mitragliatori giocattolo, visitare uno zoo dove stanno stipate in mangiatoie rarissime tigri siberiane in via d’estinzione, assistere a match di mixed martial arts (dove è mai l’arte?) tra strani ircocervi in perizoma, offrire prebende di cibo vivo a squali in gabbia e molte altre. A dire il vero sembra sia in atto una riconversione turistica del luogo per tramutarlo da market della prostituzione a polo di attrattiva di grossi centri commerciali….wow. In sintonia con il main stream “pattayense”, mi scelgo un bell’albergone tamarro di quelli che a centinaia affollano il lungomare, tale hotel Grand Palazzo, che potrà forse vantare la pregiata consulenza architettonica di Genny Savastano per lo stile sobrio ed eseenziale nonché per questi eleganti scaloni in finto marmo che con moltissima fantasia potrebbero ricordare le prospettive vanvitelliane di qualche palazzo reale italiano  Resta pure da dire che la suite, pur non eccellendo in vista sulle perenni cantieri in costruzione, ha dimensioni tali da permettere agli occupanti una partita a bocce mentre il letto è talmente grande da risultare idoneo ad un saggio ginnico con il proprio partner
Resta pure da dire che la suite, pur non eccellendo in vista sulle perenni cantieri in costruzione, ha dimensioni tali da permettere agli occupanti una partita a bocce mentre il letto è talmente grande da risultare idoneo ad un saggio ginnico con il proprio partner  e se non ne si ha uno, a fianco al ricevitore telefonico è allegata una rubrica corredata di foto anch’essa aggiornata più del già citato menu di Pornohub. È tutto qui talmente appiattito e finalizzato alla prostituzione che persino la più scontata e frequente delle domande che un ospite pone ai portieri di un albergo, quale ristorante tipico consiglierebbero per una buona cena, ha come risultato quello di lasciare gli addetti alla reception interdetti e muti, come se il cibo fosse una mera attività di sostentamento a mo’di animali da batteria indirizzati alla riproduzione. Nondimeno la sera mi pongo con animo aperto all’osservazione della enorme folla che riempie la sequela infinita di locali e go go club: atteso il peccato originario, vi sono poi mille ragioni che spingono persone da ogni angolo del globo a scegliere un posto del genere. Sorseggiando una birra, con un karaoke infernale in sottofondo, contemplo una turba composita di turisti di sesso esclusivamente maschile lanciarsi ardimentosi su ammiccanti ragazze: ci vedo l’impiegato inglese in pensione che ha lavorato una vita onestamente in banca o in un ministero e ora è costretto a pagare dissanguanti alimenti alla ex moglie ed ai figli che ingrassano davanti ad una PlayStation, il medio orientale che al suo paese ha avuto in moglie una castigata donna ricoperta di veli fino alle caviglia (qui la comprensione con tutta l buona volontà è assai minore) o il ragazzo occidentale nato di aspetto assai poco gradevole e magari di scarso reddito, a cui risulta estremamente difficile invitare al suo paese una ragazza carina a cena o a bere un drink. Mah, sono tutte considerazioni che lasciano il tempo che trovano .
e se non ne si ha uno, a fianco al ricevitore telefonico è allegata una rubrica corredata di foto anch’essa aggiornata più del già citato menu di Pornohub. È tutto qui talmente appiattito e finalizzato alla prostituzione che persino la più scontata e frequente delle domande che un ospite pone ai portieri di un albergo, quale ristorante tipico consiglierebbero per una buona cena, ha come risultato quello di lasciare gli addetti alla reception interdetti e muti, come se il cibo fosse una mera attività di sostentamento a mo’di animali da batteria indirizzati alla riproduzione. Nondimeno la sera mi pongo con animo aperto all’osservazione della enorme folla che riempie la sequela infinita di locali e go go club: atteso il peccato originario, vi sono poi mille ragioni che spingono persone da ogni angolo del globo a scegliere un posto del genere. Sorseggiando una birra, con un karaoke infernale in sottofondo, contemplo una turba composita di turisti di sesso esclusivamente maschile lanciarsi ardimentosi su ammiccanti ragazze: ci vedo l’impiegato inglese in pensione che ha lavorato una vita onestamente in banca o in un ministero e ora è costretto a pagare dissanguanti alimenti alla ex moglie ed ai figli che ingrassano davanti ad una PlayStation, il medio orientale che al suo paese ha avuto in moglie una castigata donna ricoperta di veli fino alle caviglia (qui la comprensione con tutta l buona volontà è assai minore) o il ragazzo occidentale nato di aspetto assai poco gradevole e magari di scarso reddito, a cui risulta estremamente difficile invitare al suo paese una ragazza carina a cena o a bere un drink. Mah, sono tutte considerazioni che lasciano il tempo che trovano . nella baia di fronte Pattaya so che sorge un’isoletta ammantata di verde e belle spiagge solitarie; ci sta anche un tempio, ed una signora che cucina il miglior riso fritto della Thailandia.
nella baia di fronte Pattaya so che sorge un’isoletta ammantata di verde e belle spiagge solitarie; ci sta anche un tempio, ed una signora che cucina il miglior riso fritto della Thailandia.  È un luogo assai più appartato e difficile a concepirsi attesa la vicinanza a Pattaya. Ci metto un po’ a identificarlo sulla mappa ma poi risolvo l’enigma e mi reco a Koh Larn
È un luogo assai più appartato e difficile a concepirsi attesa la vicinanza a Pattaya. Ci metto un po’ a identificarlo sulla mappa ma poi risolvo l’enigma e mi reco a Koh Larn è un luogo ove riporto a casa gli affetti di una persona a me estremamente cara, che amava restare qui a contemplare il mare. In un certo qual modo son venuto qui a far si che ciò succeda ancora, ma sono cose che tengo per me
è un luogo ove riporto a casa gli affetti di una persona a me estremamente cara, che amava restare qui a contemplare il mare. In un certo qual modo son venuto qui a far si che ciò succeda ancora, ma sono cose che tengo per me 

 Essi placavano il loro insaziabile appetito cibandosi delle pecore e degli umani, che terrorizzati provavano a sfuggire loro vivendo nelle grotte; o meglio provavano a saziarsi, giacché uno dei due un giorno, avendo terminato il cibo a sua disposizione, prese a chiedere a gran voce al fratello sul promontorio di lanciargli del cibo. La risposta del fratello non si fece attendere: non cibo bensì massi, enormi massi prese a lanciare verso il mare
Essi placavano il loro insaziabile appetito cibandosi delle pecore e degli umani, che terrorizzati provavano a sfuggire loro vivendo nelle grotte; o meglio provavano a saziarsi, giacché uno dei due un giorno, avendo terminato il cibo a sua disposizione, prese a chiedere a gran voce al fratello sul promontorio di lanciargli del cibo. La risposta del fratello non si fece attendere: non cibo bensì massi, enormi massi prese a lanciare verso il mare  come un nordico Polifemo verso la galea di Ulisse in fuga. La scorbutica risposta dovette adirare non poco l’altro ciclope che, accecato dalla fame, con un lungo balzo atterró sul promontorio e prese a lottare sanguinosamente col fratello. Combatterono per sei giorni e sei notti fin quando fu il primo, quello saltato da Mykines a prevalere e uccidere l’altro, il cui sangue prese a sgorgare copioso ed inarrestabile originando questa straordinaria cascata
come un nordico Polifemo verso la galea di Ulisse in fuga. La scorbutica risposta dovette adirare non poco l’altro ciclope che, accecato dalla fame, con un lungo balzo atterró sul promontorio e prese a lottare sanguinosamente col fratello. Combatterono per sei giorni e sei notti fin quando fu il primo, quello saltato da Mykines a prevalere e uccidere l’altro, il cui sangue prese a sgorgare copioso ed inarrestabile originando questa straordinaria cascata  Il villaggio di Gasaldur, situato appena sopra di essa, era fino a solo quindici anni fa il più irraggiungibile di tutte le Far Oer: situato all’estremità di una lunga striscia di terra che si perde nell’oceano dell’isola di Vagar, distava dal porto di Sorvagur 13 interminabili chilometri di sentieri esposti alle intemperie e che dovevano scavalcare altissime montagne. La leggenda della lotta dei giganti offre un riscontro del tutto reale e ancor oggi tangibile, che con commozione apprendo da una donna locale: l’irraggiungibile villaggio di Gasaldur fu fondato da un gruppo di balenieri della frontaliera isola di Mykines (il gigante che balza spinto dalla fame) e ancora oggi esiste un accordo tra le due piccolissime comunità per la spartizione del pescato nei terribili mesi invernali. Solo nel 2004, dopo l’agonia di un bambino, costretto col padre ad attraversare l’altissima montagna che sovrasta il villaggio per ricevere soccorso e morendo lungo il cammino nella tormenta
Il villaggio di Gasaldur, situato appena sopra di essa, era fino a solo quindici anni fa il più irraggiungibile di tutte le Far Oer: situato all’estremità di una lunga striscia di terra che si perde nell’oceano dell’isola di Vagar, distava dal porto di Sorvagur 13 interminabili chilometri di sentieri esposti alle intemperie e che dovevano scavalcare altissime montagne. La leggenda della lotta dei giganti offre un riscontro del tutto reale e ancor oggi tangibile, che con commozione apprendo da una donna locale: l’irraggiungibile villaggio di Gasaldur fu fondato da un gruppo di balenieri della frontaliera isola di Mykines (il gigante che balza spinto dalla fame) e ancora oggi esiste un accordo tra le due piccolissime comunità per la spartizione del pescato nei terribili mesi invernali. Solo nel 2004, dopo l’agonia di un bambino, costretto col padre ad attraversare l’altissima montagna che sovrasta il villaggio per ricevere soccorso e morendo lungo il cammino nella tormenta  ci si risolse alla costruzione di una strada con il più sicuro porto di Sorbagur e soprattutto allo scavo di un tunnel che bucasse quella montagna della morte. Io nondimeno, sprovvisto di automobile e a corto di generosi sostenitori dell’autostop, non ho altra alternativa che sobbarcarmi il cammino a piedi
ci si risolse alla costruzione di una strada con il più sicuro porto di Sorbagur e soprattutto allo scavo di un tunnel che bucasse quella montagna della morte. Io nondimeno, sprovvisto di automobile e a corto di generosi sostenitori dell’autostop, non ho altra alternativa che sobbarcarmi il cammino a piedi 

 me lo immagino ancora la bello solo soletto, lui i suoi teleobiettivi a fotografare le pecore sotto la pioggia. Ahahhha, fattela a piedi, pirlaaaaaaaa!!!!!!! La sera la trascorro in una meravigliosa casetta in legno col tetto in erba
me lo immagino ancora la bello solo soletto, lui i suoi teleobiettivi a fotografare le pecore sotto la pioggia. Ahahhha, fattela a piedi, pirlaaaaaaaa!!!!!!! La sera la trascorro in una meravigliosa casetta in legno col tetto in erba  ma tutto qui è dolce e incantato
ma tutto qui è dolce e incantato 
 il giorno dopo avrei l’aereo ad ora di pranzo ma sento di non poter andare via senza aver ancora solcato l’erba di queste isole incantate. Così sveglia in piena notte, anche se c’è luce ovunque
il giorno dopo avrei l’aereo ad ora di pranzo ma sento di non poter andare via senza aver ancora solcato l’erba di queste isole incantate. Così sveglia in piena notte, anche se c’è luce ovunque  immerso nella bellezza senza tempo e spazio delle Far Oer. Nel pomeriggio volo a Copenaghen e faccio pure in tempo, nello scalo, ad attraversare il ponte sull’Oresund e mettere piede in Svezia, nella città di Malmoe
immerso nella bellezza senza tempo e spazio delle Far Oer. Nel pomeriggio volo a Copenaghen e faccio pure in tempo, nello scalo, ad attraversare il ponte sull’Oresund e mettere piede in Svezia, nella città di Malmoe ma è nulla confronto alla bellezza selvaggia e primordiale delle isole.
ma è nulla confronto alla bellezza selvaggia e primordiale delle isole.  Ricordo ogni istante di questo viaggio magnifico; ormai sono in Italia e dopo tanti giorni riassaporo qualcosa di mai visto in questi giorni, il buio. Ma la luce delle Far Oer si irradia nel mio animo, oltre l’orizzonte,oltre questo mare che ammiro dalla mia isola e oltre mille mari ancora, verso quelle terre lontane e arcadiche, ove nascono, vivono e muoiono i Giganti
Ricordo ogni istante di questo viaggio magnifico; ormai sono in Italia e dopo tanti giorni riassaporo qualcosa di mai visto in questi giorni, il buio. Ma la luce delle Far Oer si irradia nel mio animo, oltre l’orizzonte,oltre questo mare che ammiro dalla mia isola e oltre mille mari ancora, verso quelle terre lontane e arcadiche, ove nascono, vivono e muoiono i Giganti